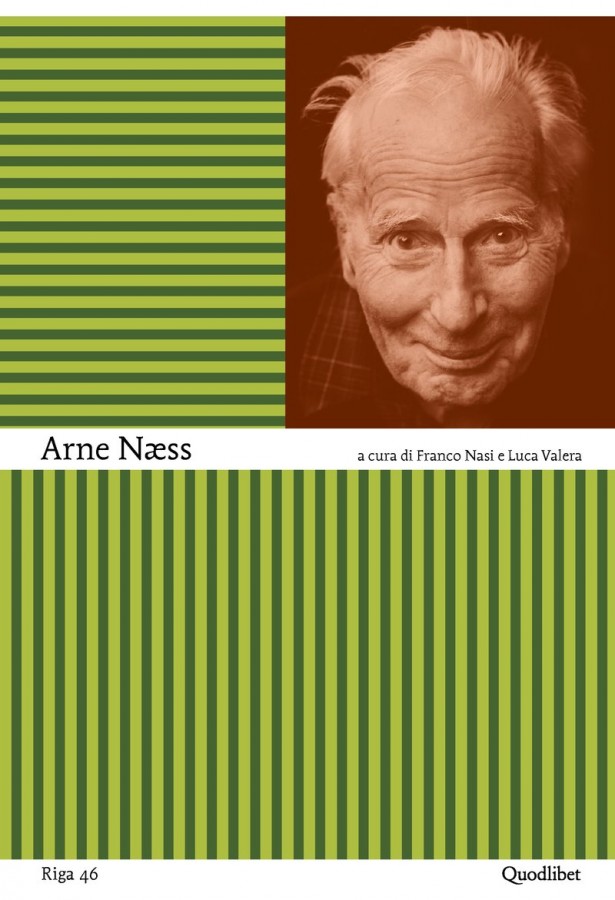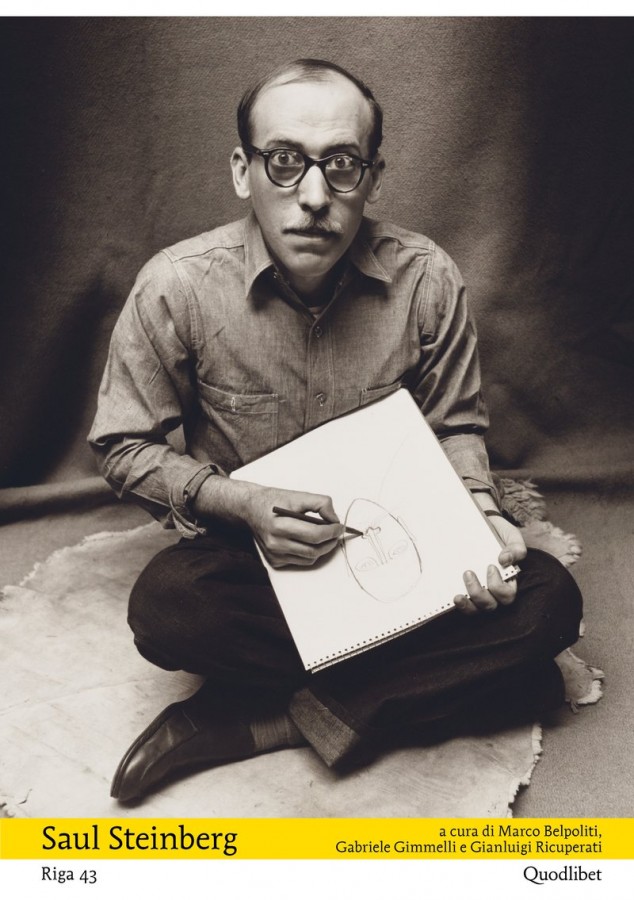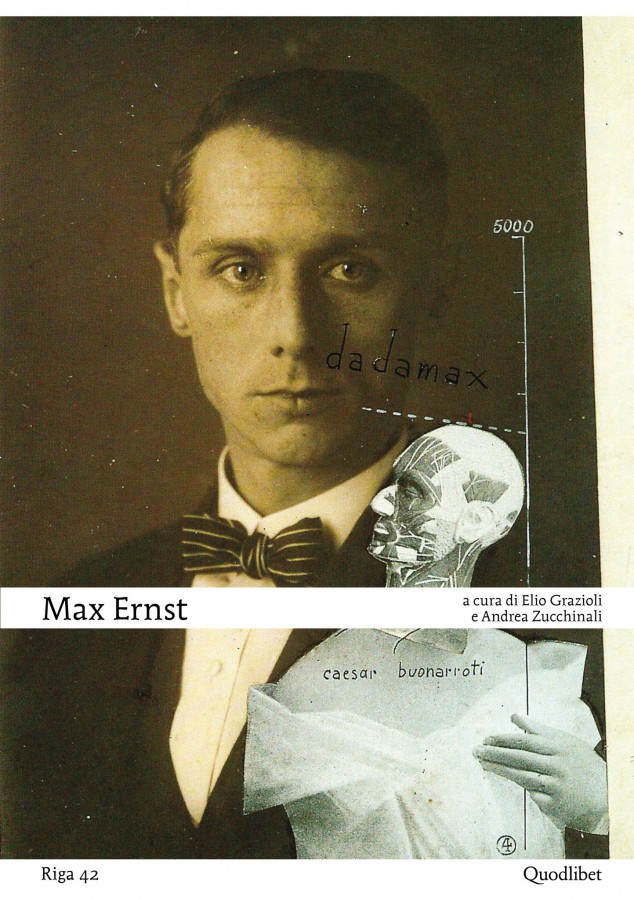Andrea Cortellessa
«Gulliver», materiali per una critica totale
Il manifesto, 04 Ottobre 2002
«Gulliver», materiali per una critica totale
Il manifesto, 04 Ottobre 2002
Nel licenziare L’infinito intrattenimento - per consapevole paradosso il suo libro più voluminoso - Maurice Blanchot scrive sull’assenza di libro. Non nel senso della tipografia soppiantata da altri media, bensì come rinuncia a quanto il Libro simboleggia: “un ordine subordinato all’unità”. Perseguita è al contrario la totalità, inseguibile solo nella forma che l’unità a tutti i livelli destruttura, il frammento: per definizione incompleto, provvisorio, virtuale. Per questo l’intrattenimento è infinito; e per questo il sottotitolo cita Mallarmé, sull’insensato gioco di scrivere: la tensione al Livre - realizzabile solo nella stellare assenza del libro stesso - è l’asintoto più seducente e, insieme, il più voraginoso spauracchio.
È il 1969. Quel decennio, le cui utopie andavano proprio allora a disseminarsi e implodere, era stato inaugurato da un’esperienza restata a sua volta incompiuta e virtuale, ma che - proprio per questo - aveva segnato Blanchot in profondità. Un progetto che aveva dato vita a una galassia di incontri, lettere e promemoria: dei quali ampia traccia (con saggi di commento e una riflessione conclusiva affidata a Francesco Leonetti) è ora nell’ultimo fascicolo di “Riga”, la rivista diretta da Marco Belpoliti ed Elio Grazioli giunta così al suo numero 21 (“Gulliver”. Progetto di una rivista internazionale, a cura di Anna Panicali, pp. 306, euro 17,00). Repertorio non del tutto inedito (lacerti se n’erano letti, fra l’altro, nel volume “Gulliver”. Carte Vittorini e Leonetti in Europa nel Sessanta, curato da Marta Temperini per Piero Manni nel 2000), ma che emerge solo ora nella sua icasticità, si può dire, d’apologo.
Alla fine del ’60 Blanchot scrive una lettera a Sartre. Gli intellettuali francesi, dopo i fatti d’Algeria, hanno prodotto un Manifesto dei 121 sul “diritto all’insubordinazione”. Sulla base di questa “comunità anonima di nomi” Blanchot propone una rivista di “critica totale”, nella quale la letteratura non suoni il piffero alla rivoluzione ma sia “reinvestita del suo senso proprio”. Sia, cioè, essa stessa rivoluzione. Non poteva certo essere Sartre a promuovere un’idea del genere, e il gesto di Blanchot sembra anzi una provocazione: la critica totale comincia proprio, infatti, dalla contestazione dell’idea sartriana di engagement (lo dice a chiare lettere, lo stesso anno, Roland Barthes).
A rilanciare l’idea è Elio Vittorini. Contatta Blanchot tramite Dionys Mascolo, coinvolge Barthes, Michel Butor e - attraverso Hans Magnus Enzensberger che allora è in Italia - Ingeborg Bachmann, Günter Grass e Uwe Johnson. Cerca l’aiuto di Pasolini e Moravia attraverso Leonetti, anello di congiunzione con l’esperienza di “Officina”, mettendo a disposizione da parte sua le risorse del “Menabò” einaudiano, nel quale ha Calvino al suo fianco. Si pensa all’inizio, come nome della rivista, a “i 60” (alludendo al concetto di “assemblea”, o “moltitudine”); ma ai tedeschi piace più “Gulliver”, insistendo (con una poesia scritta da Grass) sul relativismo culturale e sullo sradicamento. S’intuisce già la distanza fra francesi e tedeschi, che alla fine causerà il naufragio. Tanto più dopo la costruzione del Muro di Berlino, nel ’61, per i tedeschi è urgente uno strumento d’intervento diretto; mentre Blanchot insiste sulla necessità di un salto di qualità, rispetto alle vecchie forme di politicizzazione. Nell’unico vero testo programmatico scrive: “la rivista non potrà interessarsi alla realtà politica come tale, direttamente, ma sempre in modo indiretto”, e tuttavia “radicale”: scavando cioè alla “radice” degli eventi. “Quel che conta per noi è una ricerca di verità, o meglio un’esigenza forse di giustizia, per la quale l’affermazione letteraria è essenziale, proprio in virtù […] del suo rapporto esclusivo col linguaggio”. Propone Blanchot, per “dire il mondo”, due strade: da un lato la forma frammento (quelle che, richiamandosi a Char, chiama “parole in arcipelago”: nelle quali cioè il senso è sempre differito-inseguito, accogliendo “una discontinuità essenziale”), dall’altro la rinuncia alla nozione di autore verso “un superamento interiore dei nostri pensieri individuali”. Nelle lettere successive parlerà di “una coscienza collettiva di scrittori” e nel ’63, molto semplicemente, dirà: “in quanto scrittori siamo già nel comunismo”.
A spiazzare le attese degli altri collaboratori (ma anche degli editori contattati) è proprio questa radicalizzazione rivoluzionaria del concetto di rivista, in cui ogni difficoltà viene capovolta in occasione di rilancio (ad esempio le differenze linguistiche esaltano il traduttore, “uomo nostalgico, che sente nella sua lingua, come mancanza, tutto ciò che l’opera originale gli promette”). Così “si elabora, come in segreto, un modo nuovo di porre domande […] in cui, interrogando, si domandi più di quanto si possa domandare”. Proprio quest’eccesso contiene in sé, tuttavia, anche la prefigurazione dello scacco: “allora rinunceremo, ma dobbiamo verificarlo attraverso l’esperienza e, se sarà un’utopia, accettare di fallire utopicamente”. Di fatto, dopo quattro anni di discussioni (Enzensberger lamenta a un certo punto “le tendenze burocratiche e l’atmosfera da conferenza all’Unesco”), esce un numero che “doveva essere, e intanto non è più, ma può tuttavia ritrovarsi a essere, l’iniziale”. Così presenta Vittorini “Il Menabò” n° 7, che nella primavera del ’64 porta proprio il titolo Gulliver. Vi figurano alcuni dei materiali elaborati (Mascolo li paragona malinconicamente ai “rottami” che “negli stretti servono da indicazione ai navigatori”; e c’è un saggio di Starobinski sulle rovine…), ma vi circola altresì un senso di liquidazione che la malattia, che nel frattempo colpisce Vittorini, sancisce definitivamente. Eppure l’ultima parola del suo corsivo non rinuncia a un estremo rilancio: presentando i resti di Gulliver come “figura di un’imprefigurabile comunanza necessaria”, nonché “preambolo a ogni metarivista futura”.
Fa bene Anna Panicali a riannodare le vertiginose proposte di Blanchot al suo lavoro passato e futuro (il lavoro sulla forma frammento continuerà sino a La scrittura del disastro; la riflessione sul “principio di insufficienza” sino a La comunità inconfessabile, influenzando filosofi come Nancy e Agamben), ma ancora meglio fa l’anonimo editorialista della metarivista 2003 (la stessa che già con Alì Babà fece l’archeologia di un’archeologia…) a dire come le questioni sollevate da Gulliver sono sì un compendio delle illusioni generosissime, e dei disinganni amarissimi, degli anni Sessanta; ma soprattutto indicano “il punto da cui è partita la trasformazione della letteratura europea nell’ultimo ventennio del XX secolo”. Per questo definisce Blanchot, scomparso proprio mentre “Riga” stava per uscire, “maestro segreto del Novecento”. A leggere le prime parole del suo Progetto, si capisce come l’apologo in effetti non riguardi, di questi anni Zero, solo la letteratura: “ci avviciniamo a […] una mutazione dell’epoca […] significa che tutti i problemi sono d’ordine internazionale e […] che il ritorno all’idea tradizionale di pace è ormai radicalmente escluso e perfino una guerra - una buona guerra classica - potrebbe sembrare un allentamento di questo stato di tensione (di qui la tentazione della guerra)”. Un intrattenimento davvero infinito.
È il 1969. Quel decennio, le cui utopie andavano proprio allora a disseminarsi e implodere, era stato inaugurato da un’esperienza restata a sua volta incompiuta e virtuale, ma che - proprio per questo - aveva segnato Blanchot in profondità. Un progetto che aveva dato vita a una galassia di incontri, lettere e promemoria: dei quali ampia traccia (con saggi di commento e una riflessione conclusiva affidata a Francesco Leonetti) è ora nell’ultimo fascicolo di “Riga”, la rivista diretta da Marco Belpoliti ed Elio Grazioli giunta così al suo numero 21 (“Gulliver”. Progetto di una rivista internazionale, a cura di Anna Panicali, pp. 306, euro 17,00). Repertorio non del tutto inedito (lacerti se n’erano letti, fra l’altro, nel volume “Gulliver”. Carte Vittorini e Leonetti in Europa nel Sessanta, curato da Marta Temperini per Piero Manni nel 2000), ma che emerge solo ora nella sua icasticità, si può dire, d’apologo.
Alla fine del ’60 Blanchot scrive una lettera a Sartre. Gli intellettuali francesi, dopo i fatti d’Algeria, hanno prodotto un Manifesto dei 121 sul “diritto all’insubordinazione”. Sulla base di questa “comunità anonima di nomi” Blanchot propone una rivista di “critica totale”, nella quale la letteratura non suoni il piffero alla rivoluzione ma sia “reinvestita del suo senso proprio”. Sia, cioè, essa stessa rivoluzione. Non poteva certo essere Sartre a promuovere un’idea del genere, e il gesto di Blanchot sembra anzi una provocazione: la critica totale comincia proprio, infatti, dalla contestazione dell’idea sartriana di engagement (lo dice a chiare lettere, lo stesso anno, Roland Barthes).
A rilanciare l’idea è Elio Vittorini. Contatta Blanchot tramite Dionys Mascolo, coinvolge Barthes, Michel Butor e - attraverso Hans Magnus Enzensberger che allora è in Italia - Ingeborg Bachmann, Günter Grass e Uwe Johnson. Cerca l’aiuto di Pasolini e Moravia attraverso Leonetti, anello di congiunzione con l’esperienza di “Officina”, mettendo a disposizione da parte sua le risorse del “Menabò” einaudiano, nel quale ha Calvino al suo fianco. Si pensa all’inizio, come nome della rivista, a “i 60” (alludendo al concetto di “assemblea”, o “moltitudine”); ma ai tedeschi piace più “Gulliver”, insistendo (con una poesia scritta da Grass) sul relativismo culturale e sullo sradicamento. S’intuisce già la distanza fra francesi e tedeschi, che alla fine causerà il naufragio. Tanto più dopo la costruzione del Muro di Berlino, nel ’61, per i tedeschi è urgente uno strumento d’intervento diretto; mentre Blanchot insiste sulla necessità di un salto di qualità, rispetto alle vecchie forme di politicizzazione. Nell’unico vero testo programmatico scrive: “la rivista non potrà interessarsi alla realtà politica come tale, direttamente, ma sempre in modo indiretto”, e tuttavia “radicale”: scavando cioè alla “radice” degli eventi. “Quel che conta per noi è una ricerca di verità, o meglio un’esigenza forse di giustizia, per la quale l’affermazione letteraria è essenziale, proprio in virtù […] del suo rapporto esclusivo col linguaggio”. Propone Blanchot, per “dire il mondo”, due strade: da un lato la forma frammento (quelle che, richiamandosi a Char, chiama “parole in arcipelago”: nelle quali cioè il senso è sempre differito-inseguito, accogliendo “una discontinuità essenziale”), dall’altro la rinuncia alla nozione di autore verso “un superamento interiore dei nostri pensieri individuali”. Nelle lettere successive parlerà di “una coscienza collettiva di scrittori” e nel ’63, molto semplicemente, dirà: “in quanto scrittori siamo già nel comunismo”.
A spiazzare le attese degli altri collaboratori (ma anche degli editori contattati) è proprio questa radicalizzazione rivoluzionaria del concetto di rivista, in cui ogni difficoltà viene capovolta in occasione di rilancio (ad esempio le differenze linguistiche esaltano il traduttore, “uomo nostalgico, che sente nella sua lingua, come mancanza, tutto ciò che l’opera originale gli promette”). Così “si elabora, come in segreto, un modo nuovo di porre domande […] in cui, interrogando, si domandi più di quanto si possa domandare”. Proprio quest’eccesso contiene in sé, tuttavia, anche la prefigurazione dello scacco: “allora rinunceremo, ma dobbiamo verificarlo attraverso l’esperienza e, se sarà un’utopia, accettare di fallire utopicamente”. Di fatto, dopo quattro anni di discussioni (Enzensberger lamenta a un certo punto “le tendenze burocratiche e l’atmosfera da conferenza all’Unesco”), esce un numero che “doveva essere, e intanto non è più, ma può tuttavia ritrovarsi a essere, l’iniziale”. Così presenta Vittorini “Il Menabò” n° 7, che nella primavera del ’64 porta proprio il titolo Gulliver. Vi figurano alcuni dei materiali elaborati (Mascolo li paragona malinconicamente ai “rottami” che “negli stretti servono da indicazione ai navigatori”; e c’è un saggio di Starobinski sulle rovine…), ma vi circola altresì un senso di liquidazione che la malattia, che nel frattempo colpisce Vittorini, sancisce definitivamente. Eppure l’ultima parola del suo corsivo non rinuncia a un estremo rilancio: presentando i resti di Gulliver come “figura di un’imprefigurabile comunanza necessaria”, nonché “preambolo a ogni metarivista futura”.
Fa bene Anna Panicali a riannodare le vertiginose proposte di Blanchot al suo lavoro passato e futuro (il lavoro sulla forma frammento continuerà sino a La scrittura del disastro; la riflessione sul “principio di insufficienza” sino a La comunità inconfessabile, influenzando filosofi come Nancy e Agamben), ma ancora meglio fa l’anonimo editorialista della metarivista 2003 (la stessa che già con Alì Babà fece l’archeologia di un’archeologia…) a dire come le questioni sollevate da Gulliver sono sì un compendio delle illusioni generosissime, e dei disinganni amarissimi, degli anni Sessanta; ma soprattutto indicano “il punto da cui è partita la trasformazione della letteratura europea nell’ultimo ventennio del XX secolo”. Per questo definisce Blanchot, scomparso proprio mentre “Riga” stava per uscire, “maestro segreto del Novecento”. A leggere le prime parole del suo Progetto, si capisce come l’apologo in effetti non riguardi, di questi anni Zero, solo la letteratura: “ci avviciniamo a […] una mutazione dell’epoca […] significa che tutti i problemi sono d’ordine internazionale e […] che il ritorno all’idea tradizionale di pace è ormai radicalmente escluso e perfino una guerra - una buona guerra classica - potrebbe sembrare un allentamento di questo stato di tensione (di qui la tentazione della guerra)”. Un intrattenimento davvero infinito.