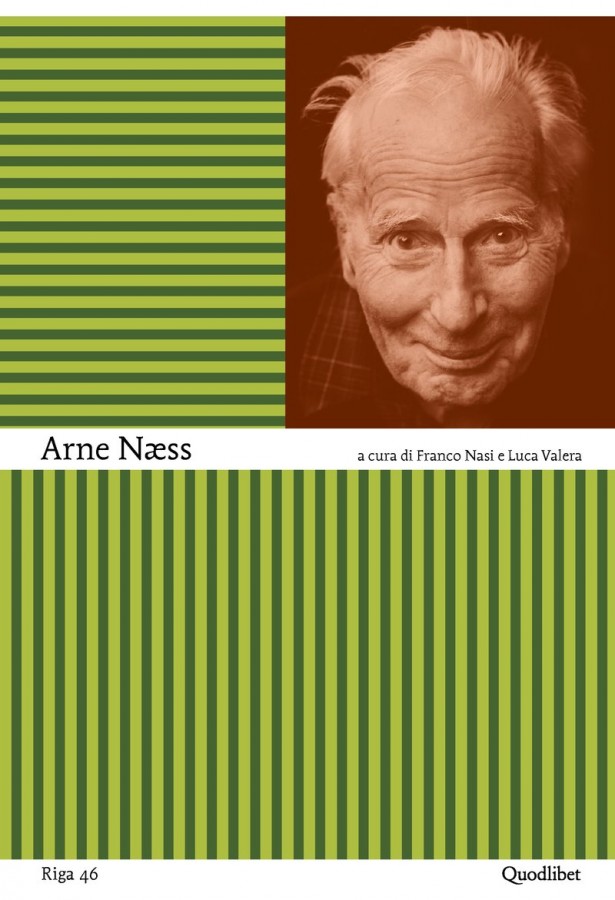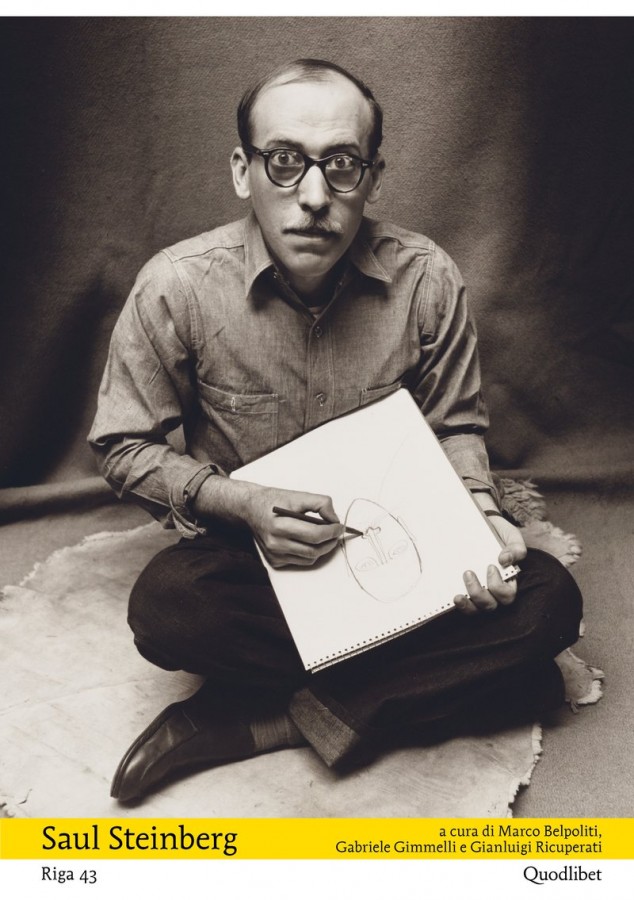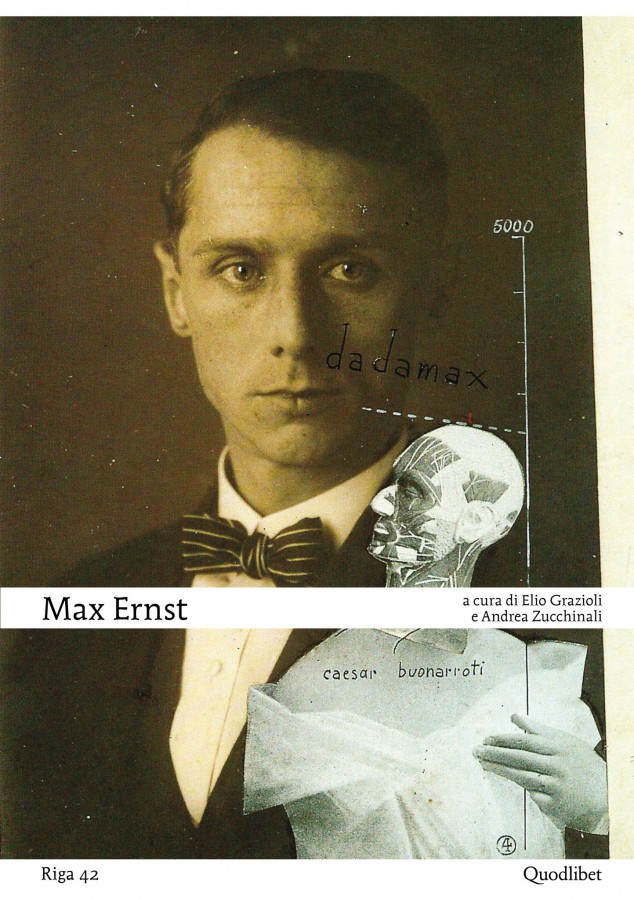Maurizio Ciampa
Giacometti, le figure dell'impossibile verso la fine del tempo
Il manifesto, 20 Dicembre 1991
Giacometti, le figure dell'impossibile verso la fine del tempo
Il manifesto, 20 Dicembre 1991
Molto semplicemente l’Alberto Giacometti di Yves Bonnefoy è un libro straordinario. Mira al cuore di un enigma: è destinato allo scacco chi pretende di rappresentare il mondo visibile, di trattenerlo, di coagularlo in un segno anche esile, di addensarlo in una forma anche precaria?
Bonnefoy insegue Giacometti per 500 pagine. Mai il suo sguardo arretra. Mai soccombe. Mai s’arrende all’oscurità. S’incunea in angoli stretti. Ma con discrezione. Con grazia. Penetra, con gesti misurati, nell’estenuante successione dei fallimenti e delle speranze, dei dubbi e delle decisioni. Ripercorre i suoi paesaggi lontani - lo spazio aspro, chiuso della Val Bregaglia, fra l’Engadina e il confine italiano -, l’angoscia che sale da un paradiso perduto, da un felicità interrotta, gli interni familiari che racchiudono, custodiscono, come un segreto, le promesse della felicità e, sempre incombenti, le minacce dell’angoscia. Poi Parigi, l’atelier leggendario in rue Hippolyte-Maindron 46, dove Giacometti spoglia il visibile, lo prosciuga; l’ebrezza surrealista, e oltre, gli «anni della decisione», la «possibilità di provare» («I tentativi sono tutto», dice Giacometti) ma restando in bilico sul vuoto, fino all’epilogo nella «luce ghiacciata della sua valle».
Racconta Giacometti che, da bambino, del mondo esterno arrivava cogliere «solo ciò che appaga il suo piacere». Il ricordo di un monolite dorato è la fonte di quell’amichevole relazione con il mondo circostante: «immediatamente considerai quella pietra un’amica, una creatura animata dalle migliori intenzioni nei nostri confronti; ci chiamava, ci sorrideva, come qualcuno già conosciuto e amato nel passato, ritrovato con stupore e gioia infiniti». La vita scaglierà quel bambino lontano dalla felicità percettiva dell’infanzia. In un luogo estraneo e insicuro. Minaccioso. Appena valicata la soglia dell’adolescenza, Giacometti sarà raggiunto da immagini di morte. Lo separeranno, quelle immagini, dal rigoglio visivo della prima giovinezza. Definitivamente. Gli vieteranno l’esuberanza delle apparenze. Nasceranno così le sue figure vacillanti e perennemente in cammino, quasi proverbiali nell’arte di questo secolo, ossessivamente transitorie, così piccole - almeno per un periodo - da essere contenute in una scatola di fiammiferi. Ricordiamo la serie dell’Uomo che cammina fra il 1947 e il 1948, i Tre uomini che camminano del 1948, l’Uomo che vacilla del 1950. Ma Giacometti ha dato vita a una folla di esseri precari, emblemi di una solitudine senza riparo, che portano la distanza come una ferita, prigionieri di una progressiva pietrificazione dell’essere. Non è padrone di sé l’uomo. Transita.
«Dove vanno?» - si chiede Jean Genet che ad Alberto Giacometti dedica pagine illuminanti (ora ripresentate nel primo numero della rivista Riga interamente dedicato a Giacometti). Sì, dove vanno le figure di Giacometti? Semplicemente - come dice Genet - «stanno al fondo del tempo, all’origine di tutto?» si muovono con un «abisso al fianco» come indica Sartre? Varrebbe la pena ricordare i venticinque anni dalla morte di Alberto Giacometti (muore l’11 gennaio 1966; era nato il 10 ottobre 1901) solo per trattenere la memoria di uno scacco? «Non può esserci che scacco - dice in un’intervista con Peter Schneider del 1961 -. L’unica cosa che mi appassiona è cercare comunque di avvicinarmi a questa visione che mi pare impossibile rendere». Privato di ogni avere, l’essere è troppo spoglio, impalpabile come la polvere che avvolge l’atelier di rue Hyppolite-Maindron.
La figura umana è sempre in procinto di sciogliersi nelnulla. Giacometti coglie uomini prossimi a scomparire: galleggiano in uno spazio irreale, vi affondano, vi precipitano, o restano in bilico, come rappresi in una vertigine. Spettri, non uomini. Ombre.
Eppure Genet parla di Giacometti come di «un uomo che non ha mai smesso di osare». Certo non osa chi si arrende al nulla. Qual è dunque il suo azzardo? È vero: nessuna presa è possibile sulla realtà. Erosa dalla finitezza, essa frana, si dissolve. E poco può la forma: «non ce la fa ad impadronirsi della realtà» Come se il mondo costantemente arretrasse e ne sgusciasse fuori. Lo sa bene Giacometti. Egli attende al computo quotidiano di un fallimento. È un avamposto il suo atelier. Una frontiera nella regione del visibile. Ma le incursioni dell’artista non vanno a buon fine. Ne torna estenuato. Ha rinunciato a una «vita decente» vive in «luoghi di passaggio», si è ritratto da «ogni forma di possesso». Non basta: «più si avvicina alle cose, più cresce il vuoto che gliele separa». Più la ritrae, più la realtà si smembra. Più si attiene al vero, più esso si allontana. L’impossibile lo stringe. Eppure egli dichiara: «Non ho niente da chiedere se non di poter continuare perdutamente».
Così sarà. Giacometti continua: «Se a quel punto, invece di abbandonare, si insiste, è il solo momento in cui vi è la possibilità di fare un piccolo passo in avanti». Un piccolo passo non porta a scavalcare il muro dell’impossibile. Giacometti lo assedia. Alla base di quel muro è la sua lotta.
C’è una frase di Antonin Artaud che ben si adatta a Giacometti. È del 1946. Artaud è appena uscito dal manicomio di Rodez. «Tutta la mia opera è costruita su questa strage, su questa mischia di fuochi spenti, di cristalli e di eccidi, non si fa né si dice nulla, ma si soffre, si dispera e ci si batte, sì, credo che in realtà ci si batta. La lotta sarà apprezzata, giudicata, giustificata? No. Avrà un nome? Nemmeno nominare la battaglia significa forse uccidere il nulla. Ma soprattutto fermare la vita, non fermeremo mai la vita».
Non fermerà la vita, Giacometti. Come Artaud. Dispererà di poterla rappresentare. Rinvenirà il vuoto al suo centro. Come Artaud, ingaggerà una battaglia senza nome. Nella luce stemperata, tenue, dell’inverno della Val Bregaglia Giacometti andrà incontro al suo epilogo. Che cosa lascia dietro di sé? Solo un resoconto della precarietà? O la scia di un scacco? O l’esercizio di un dubbio metodico come vuole Michel Leiris? Il libro di Yves Bonnefoy ci fa attraversare tutto questo. Mostra un paesaggio grandioso, per quanto irregolare, spezzato, discontinuo, un’enorme distesa d’immagini dove l’immagine stessa è messa in questione. Ma la linea di quel paesaggio non è la sola rilevazione dell’impossibile. Bonnefoy lo indica con esattezza. Accanto allo scacco si forma la speranza. A furia di scavare le sue figure fino a quasi spezzarle, Giacometti trova «l’energia straordinaria che fa si che l’essere vivente continui ad essere in ogni istante». Sopravvive dunque l’umanità al «sussulto dell’essere». Solo provando l’angoscia che il vivente si spenga, «ci si può tuttavia rendere conto che esso vive». Solo il terrore apre uno squarcio nel visibile. Così, attraversando lo spazio che le separava, gli «abissi di vuoto», le figure di Giacometti si fanno incontro l’una all’altra. Vacillando, incrociando i loro passi. I suoi uomini che camminano lungo una strada apparentemente cieca, s’imbattono in una piazza. La piazza (quattro uomini e una donna) è del 1948. andrà anche oltre Giacometti. Non aveva detto: «Non ho niente da chiedere no di poter continuare perdutamente»? dunque continua. Si approssima alla presenza degli esseri. Di questo solo ormai dà conto. I sogni, i desideri, le illusioni, le speranze, le inquietudini, piegano verso l’accettazione. Questo legge Bonnefoy nel Diego seduto del 1964. infine Lotar III l’ultima delle sue sculture del 1965. «Essa si eleva - dice Bonnefoy - nell’assenza, nel nulla assoluto, con una rettitudine, un coraggio che da soli riuscirebbero a provare che il fatto umano non è comparabile a nessun altro».
Questo è il coraggio di Alberto Giacometti. Capiamo ora, afferrato l’intreccio paradossale del suo scacco e della sua speranza - ce lo consente il libro di Yves Bonnefoy -, perché Jean Genet lo considerasse «un uomo che non ha mai smesso di osare». E capiamo anche perché su quel singolare fallimento o su quella singolare speranza occorra tornare, soffermandoci, raccogliendo i gesti malfermi, dubbiosi, di un’arte - quella di Alberto Giacometti - che sembra scivolare continuamente nell’impotenza, nel silenzio, nell’immobilità.
Il primo numero di Riga fa esattamente questo: chiede di tornare su Giacometti, «di non farla finita tanto presto con il ‘fallimento’ di Giacometti, un fallimento di non facile catalogazione o redenzione». Riga restituisce la leggenda, da risonanza al suo mito attraverso i saggi di Leiris e di Genet, di Ponte e di Sartre, di Starobinski, attraverso i suoi stessi scritti. Si entra così nello spazio desolato dell’atelier di Giacometti, «minuscolo, scalcinato, polveroso», rue Hyppolite-Maindron 46, XIV arrondissement: si conosce la folta schiera dei suoi abitanti, le circostanze da cui prendono forma, lo strato di paura sul quale quotidianamente l’artista poggia i piedi. Ma questo non basterebbe a riprendere le fila del fallimento di Giacometti. Non basterebbe a identificarlo, a nominarlo, a circoscrivere il luogo in cui la speranza si forma. Riga apre altre strade percorse da Reinhold Hohl, James Lord, Casimiro di Crescenzo, Marco Belpoliti, Claudio Fontana, Elio Grazioli, Federico De Leonardis, Antonio Mottolese. Nel saggio di Belpoliti colgo un’immagine che potrebbe essere risolutiva: quella del cacciatore Gracco estratta da Kafka. Per un fatale errore di rotta, mai il cacciatore Gracco arriverà al termine del suo viaggio. Resterà per via. Come le figure di Giacometti.
Bonnefoy insegue Giacometti per 500 pagine. Mai il suo sguardo arretra. Mai soccombe. Mai s’arrende all’oscurità. S’incunea in angoli stretti. Ma con discrezione. Con grazia. Penetra, con gesti misurati, nell’estenuante successione dei fallimenti e delle speranze, dei dubbi e delle decisioni. Ripercorre i suoi paesaggi lontani - lo spazio aspro, chiuso della Val Bregaglia, fra l’Engadina e il confine italiano -, l’angoscia che sale da un paradiso perduto, da un felicità interrotta, gli interni familiari che racchiudono, custodiscono, come un segreto, le promesse della felicità e, sempre incombenti, le minacce dell’angoscia. Poi Parigi, l’atelier leggendario in rue Hippolyte-Maindron 46, dove Giacometti spoglia il visibile, lo prosciuga; l’ebrezza surrealista, e oltre, gli «anni della decisione», la «possibilità di provare» («I tentativi sono tutto», dice Giacometti) ma restando in bilico sul vuoto, fino all’epilogo nella «luce ghiacciata della sua valle».
Racconta Giacometti che, da bambino, del mondo esterno arrivava cogliere «solo ciò che appaga il suo piacere». Il ricordo di un monolite dorato è la fonte di quell’amichevole relazione con il mondo circostante: «immediatamente considerai quella pietra un’amica, una creatura animata dalle migliori intenzioni nei nostri confronti; ci chiamava, ci sorrideva, come qualcuno già conosciuto e amato nel passato, ritrovato con stupore e gioia infiniti». La vita scaglierà quel bambino lontano dalla felicità percettiva dell’infanzia. In un luogo estraneo e insicuro. Minaccioso. Appena valicata la soglia dell’adolescenza, Giacometti sarà raggiunto da immagini di morte. Lo separeranno, quelle immagini, dal rigoglio visivo della prima giovinezza. Definitivamente. Gli vieteranno l’esuberanza delle apparenze. Nasceranno così le sue figure vacillanti e perennemente in cammino, quasi proverbiali nell’arte di questo secolo, ossessivamente transitorie, così piccole - almeno per un periodo - da essere contenute in una scatola di fiammiferi. Ricordiamo la serie dell’Uomo che cammina fra il 1947 e il 1948, i Tre uomini che camminano del 1948, l’Uomo che vacilla del 1950. Ma Giacometti ha dato vita a una folla di esseri precari, emblemi di una solitudine senza riparo, che portano la distanza come una ferita, prigionieri di una progressiva pietrificazione dell’essere. Non è padrone di sé l’uomo. Transita.
«Dove vanno?» - si chiede Jean Genet che ad Alberto Giacometti dedica pagine illuminanti (ora ripresentate nel primo numero della rivista Riga interamente dedicato a Giacometti). Sì, dove vanno le figure di Giacometti? Semplicemente - come dice Genet - «stanno al fondo del tempo, all’origine di tutto?» si muovono con un «abisso al fianco» come indica Sartre? Varrebbe la pena ricordare i venticinque anni dalla morte di Alberto Giacometti (muore l’11 gennaio 1966; era nato il 10 ottobre 1901) solo per trattenere la memoria di uno scacco? «Non può esserci che scacco - dice in un’intervista con Peter Schneider del 1961 -. L’unica cosa che mi appassiona è cercare comunque di avvicinarmi a questa visione che mi pare impossibile rendere». Privato di ogni avere, l’essere è troppo spoglio, impalpabile come la polvere che avvolge l’atelier di rue Hyppolite-Maindron.
La figura umana è sempre in procinto di sciogliersi nelnulla. Giacometti coglie uomini prossimi a scomparire: galleggiano in uno spazio irreale, vi affondano, vi precipitano, o restano in bilico, come rappresi in una vertigine. Spettri, non uomini. Ombre.
Eppure Genet parla di Giacometti come di «un uomo che non ha mai smesso di osare». Certo non osa chi si arrende al nulla. Qual è dunque il suo azzardo? È vero: nessuna presa è possibile sulla realtà. Erosa dalla finitezza, essa frana, si dissolve. E poco può la forma: «non ce la fa ad impadronirsi della realtà» Come se il mondo costantemente arretrasse e ne sgusciasse fuori. Lo sa bene Giacometti. Egli attende al computo quotidiano di un fallimento. È un avamposto il suo atelier. Una frontiera nella regione del visibile. Ma le incursioni dell’artista non vanno a buon fine. Ne torna estenuato. Ha rinunciato a una «vita decente» vive in «luoghi di passaggio», si è ritratto da «ogni forma di possesso». Non basta: «più si avvicina alle cose, più cresce il vuoto che gliele separa». Più la ritrae, più la realtà si smembra. Più si attiene al vero, più esso si allontana. L’impossibile lo stringe. Eppure egli dichiara: «Non ho niente da chiedere se non di poter continuare perdutamente».
Così sarà. Giacometti continua: «Se a quel punto, invece di abbandonare, si insiste, è il solo momento in cui vi è la possibilità di fare un piccolo passo in avanti». Un piccolo passo non porta a scavalcare il muro dell’impossibile. Giacometti lo assedia. Alla base di quel muro è la sua lotta.
C’è una frase di Antonin Artaud che ben si adatta a Giacometti. È del 1946. Artaud è appena uscito dal manicomio di Rodez. «Tutta la mia opera è costruita su questa strage, su questa mischia di fuochi spenti, di cristalli e di eccidi, non si fa né si dice nulla, ma si soffre, si dispera e ci si batte, sì, credo che in realtà ci si batta. La lotta sarà apprezzata, giudicata, giustificata? No. Avrà un nome? Nemmeno nominare la battaglia significa forse uccidere il nulla. Ma soprattutto fermare la vita, non fermeremo mai la vita».
Non fermerà la vita, Giacometti. Come Artaud. Dispererà di poterla rappresentare. Rinvenirà il vuoto al suo centro. Come Artaud, ingaggerà una battaglia senza nome. Nella luce stemperata, tenue, dell’inverno della Val Bregaglia Giacometti andrà incontro al suo epilogo. Che cosa lascia dietro di sé? Solo un resoconto della precarietà? O la scia di un scacco? O l’esercizio di un dubbio metodico come vuole Michel Leiris? Il libro di Yves Bonnefoy ci fa attraversare tutto questo. Mostra un paesaggio grandioso, per quanto irregolare, spezzato, discontinuo, un’enorme distesa d’immagini dove l’immagine stessa è messa in questione. Ma la linea di quel paesaggio non è la sola rilevazione dell’impossibile. Bonnefoy lo indica con esattezza. Accanto allo scacco si forma la speranza. A furia di scavare le sue figure fino a quasi spezzarle, Giacometti trova «l’energia straordinaria che fa si che l’essere vivente continui ad essere in ogni istante». Sopravvive dunque l’umanità al «sussulto dell’essere». Solo provando l’angoscia che il vivente si spenga, «ci si può tuttavia rendere conto che esso vive». Solo il terrore apre uno squarcio nel visibile. Così, attraversando lo spazio che le separava, gli «abissi di vuoto», le figure di Giacometti si fanno incontro l’una all’altra. Vacillando, incrociando i loro passi. I suoi uomini che camminano lungo una strada apparentemente cieca, s’imbattono in una piazza. La piazza (quattro uomini e una donna) è del 1948. andrà anche oltre Giacometti. Non aveva detto: «Non ho niente da chiedere no di poter continuare perdutamente»? dunque continua. Si approssima alla presenza degli esseri. Di questo solo ormai dà conto. I sogni, i desideri, le illusioni, le speranze, le inquietudini, piegano verso l’accettazione. Questo legge Bonnefoy nel Diego seduto del 1964. infine Lotar III l’ultima delle sue sculture del 1965. «Essa si eleva - dice Bonnefoy - nell’assenza, nel nulla assoluto, con una rettitudine, un coraggio che da soli riuscirebbero a provare che il fatto umano non è comparabile a nessun altro».
Questo è il coraggio di Alberto Giacometti. Capiamo ora, afferrato l’intreccio paradossale del suo scacco e della sua speranza - ce lo consente il libro di Yves Bonnefoy -, perché Jean Genet lo considerasse «un uomo che non ha mai smesso di osare». E capiamo anche perché su quel singolare fallimento o su quella singolare speranza occorra tornare, soffermandoci, raccogliendo i gesti malfermi, dubbiosi, di un’arte - quella di Alberto Giacometti - che sembra scivolare continuamente nell’impotenza, nel silenzio, nell’immobilità.
Il primo numero di Riga fa esattamente questo: chiede di tornare su Giacometti, «di non farla finita tanto presto con il ‘fallimento’ di Giacometti, un fallimento di non facile catalogazione o redenzione». Riga restituisce la leggenda, da risonanza al suo mito attraverso i saggi di Leiris e di Genet, di Ponte e di Sartre, di Starobinski, attraverso i suoi stessi scritti. Si entra così nello spazio desolato dell’atelier di Giacometti, «minuscolo, scalcinato, polveroso», rue Hyppolite-Maindron 46, XIV arrondissement: si conosce la folta schiera dei suoi abitanti, le circostanze da cui prendono forma, lo strato di paura sul quale quotidianamente l’artista poggia i piedi. Ma questo non basterebbe a riprendere le fila del fallimento di Giacometti. Non basterebbe a identificarlo, a nominarlo, a circoscrivere il luogo in cui la speranza si forma. Riga apre altre strade percorse da Reinhold Hohl, James Lord, Casimiro di Crescenzo, Marco Belpoliti, Claudio Fontana, Elio Grazioli, Federico De Leonardis, Antonio Mottolese. Nel saggio di Belpoliti colgo un’immagine che potrebbe essere risolutiva: quella del cacciatore Gracco estratta da Kafka. Per un fatale errore di rotta, mai il cacciatore Gracco arriverà al termine del suo viaggio. Resterà per via. Come le figure di Giacometti.