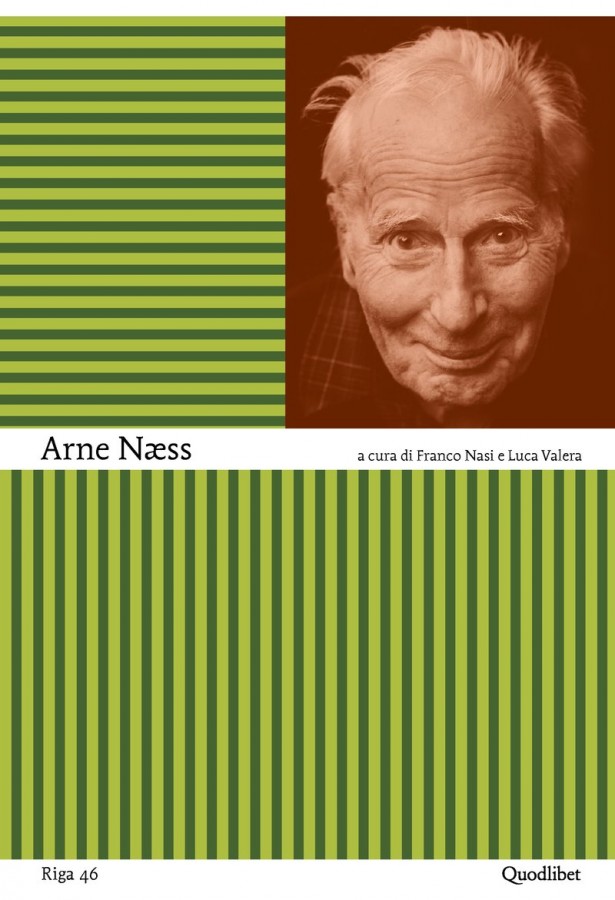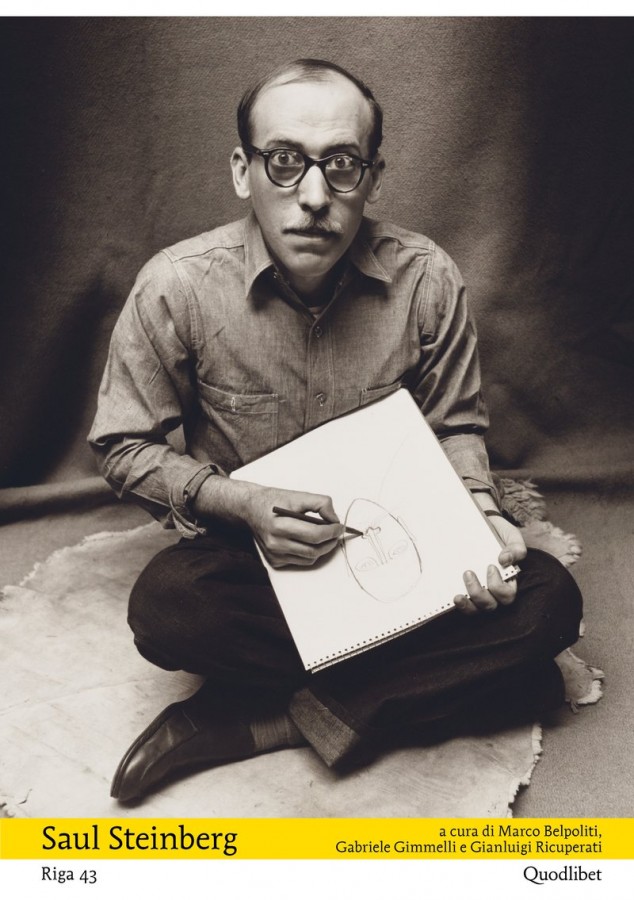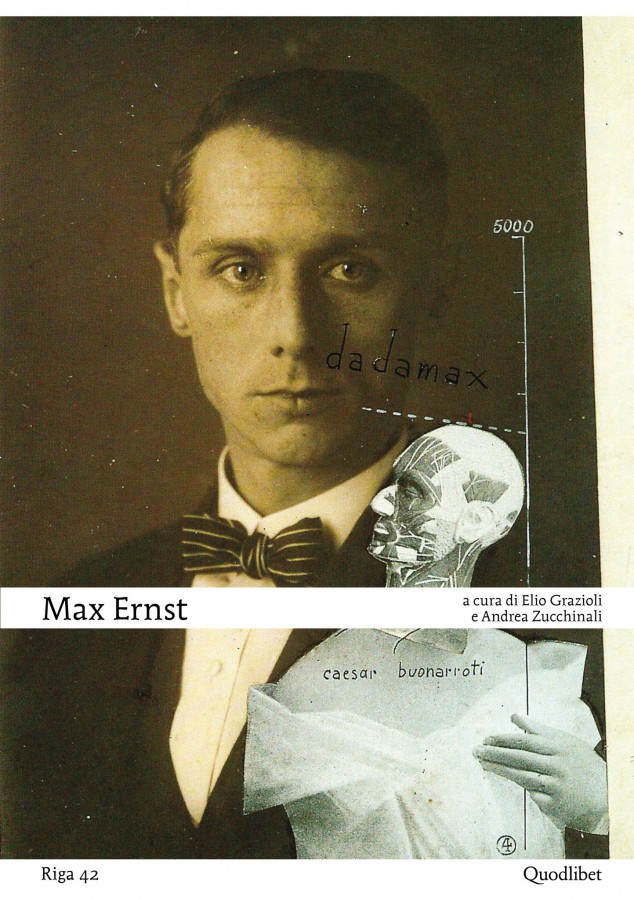Alessandro Fambrini
Furio Jesi
Osservatorio Critico della Germanistica, Gennaio 2011
Furio Jesi
Osservatorio Critico della Germanistica, Gennaio 2011
«Riga», la rivista-libro di Marcos y Marcos giunta al suo numero 31, dedica a Furio Jesi un volume curato da Marco Belpoliti ed Enrico Manera e, secondo la ricetta collaudata della serie, presenta un denso corpus di materiali «di Jesi e su Jesi», come recita il retrocopertina, «per entrare nel vivo della sua officina letteraria». Una formuletta un po’ abusata: così come un po’ trite sembrano alcune espressioni dei due curatori nell’introduzione, che nascono probabilmente dall’intenzione di sottrarre Jesi a un orizzonte culturale avvertito come limitato e opprimente rispetto alla ricchezza di fermenti che caratterizza l’autore torinese, ma che, tese a riscattarlo dal luogo comune, finiscono per riprecipitarlo in altri luoghi comuni non meno angusti. Così apprendiamo che Jesi è «uno studioso dall’impressionante varietà di interessi e dalla straordinaria capacità di scrittura» che unisce «la curiosità del bambino al lucido rigore dell’intellettuale» e che la sua tangenzialità di pensatore si rispecchia in un percorso anche professionale che non va a ibridarsi con le forme riconosciute e costituite, ma lo vede piuttosto svolgere il proprio lavoro di ricerca solitario e indipendente «senza appartenere all’accademia e alle sue logiche» (p. 8). Ora, se è vero che Jesi non aveva compiuto studi regolari, ciò era avvenuto perché a sedici anni, quando già aveva pubblicato i suoi primi saggi di egittologia, si era ritirato dalla scuola ritenendola inadeguata alle proprie esigenze formative. In quello stesso anno, il 1957, Jesi partecipava al XXIV Congresso internazionale degli Orientalisti a Monaco di Baviera con la relazione Études cosmogoniques, fondava la rivista «Archivio Internazionale di Etnografia e Preistoria» e trascorreva un periodo nel Monastero della Trasfigurazione presso le Meteore, in Tessaglia (a proposito di questo soggiorno, in una lettera di qualche anno dopo e compresa in questo volume, Jesi racconta di aver vissuto «parecchio tempo» in concentrazione claustrale «con i pochi monaci, tentando di vivere le loro esperienze e affondando nella tenebra di Plotino», per poi da Plotino «passare allo Pseudo-Dionigi» [p. 43]). Esperienze non comuni, un percorso di formazione eccentrico, ma estremamente raffinato: eccesso e non difetto di elitarismo culturale, di cui sono impregnati i primi scritti e che negli anni si stempera in un sempre maggiore ampliamento di raggio del cerchio dei propri interessi che, pur continuando a concentrarsi su fenomeni marginali o apparentemente minori, ne fanno il fuoco per una riflessione e una ricostruzione sempre più vasta di intrecci tra individui, popoli e mondo. Del resto Jesi, pur essendo fortemente caratterizzato nella propria individualità, fu sempre integrato nell’industria culturale, lavorando per UTET dal 1961 al ’69, pubblicando per Einaudi – dove si ritrova sotto l’ala protettrice di Calvino – fin dagli anni Sessanta e salendo in cattedra universitaria a poco più di trent’anni, partecipando liberamente (per quanto lo «spinto da famiglia e amici» che si legge a p. 17 nella Biografia inserita in questo volume induca a immaginare una sua riluttanza: più corretto ci sembra parlare di un incoraggiamento all’intrapresa da parte di Cesare Cases e di Claudio Magris, due germanisti e intellettuali che gravitavano nell’orbita torinese ed einaudiana di quegli anni) a un concorso per titoli: e nel riconoscerlo non si toglie nulla alla sua originalità e al suo impegno.
Poco male, comunque: perché il volume offre una ricca messe di materiali, grazie ai quali la figura di Jesi acquista un vivido rilievo umano oltre che autoriale: «saggi e articoli su preistoria e archeologia, mito e mitologia, letteratura e critica, scritti politici, poesie, lettere, foto, materiali inediti» (p. 9), presentati in ordine cronologico per quanto riguarda le opere di Jesi, in ordine tematico invece per quanto riguarda i contributi a lui dedicati, a formare un mosaico dal quale la figura dello studioso torinese emerge in tutta la sua sfaccettata complessità. Agli interventi «storici» su Jesi, tratti da fonti eterogenee che vanno da articoli su giornali e riviste a introduzioni a opere dello stesso Jesi a contributi in atti di convegni o in numeri monografici di riviste culturali, si affiancano in numero minore scritti progettati e costruiti per l’occasione. In tutto ciò, è lo Jesi mitologo e critico della tradizione a fare la parte del leone, ed è probabilmente giusto che sia così: e tuttavia non secondario appare il rilievo che anche in questa rassegna acquista lo Jesi germanista, al quale non solo danno voce alcune testimonianze di studiosi che lo conobbero e gli furono vicini, quali Ferruccio Masini (Risalire il Nilo, dal volume omonimo dedicato proprio a Jesi – Risalire il Nilo. Mito fiaba allegoria – del 1983), Giorgio Cusatelli (Un difensore della ragione, da «L'Indice» 4 – 1987) e Cesare Cases (la recensione a L’ultima notte (sullo stesso numero de «L'Indice»), o che contribuiscono nel panorama corrente ad accompagnarne criticamente la vicenda editoriale e in tal modo a proseguirne la traccia, come Giulio Schiavoni (L’uomo segreto che è in noi, da «Immediati dintorni», 1989), ma anche di altri che affrontano il versante jesiano più direttamente affacciato sulla letteratura tedesca. E’ questo, almeno parzialmente, il caso del contributo di Michele Cometa, L’immagine in Jesi (pp. 258-270) – nel quale, tuttavia, la traccia dello Jesi germanista si amplifica e si disperde in quella dello Jesi archeologo che da descrittore di immagini ne diviene creatore – e soprattutto di quello di Margherita Cottone, Jesi legge Rilke: «Le Duineser Elegien» (pp. 217-231), in cui è messo a fuoco il filo che intreccia il lavoro dello studioso torinese a uno dei testi che più lo affascinò e lo impegnò in un’opera di inesausto confronto, dal quale discendono anche prodotti poetici in cui il modello rilkiano vibra e rivive con note personalissime e insieme impossibili senza quel modello (penso alla raccolta L’esilio, 1970, di cui questo volume riporta un esempio, Katabasis; nella lettura che ne dà Raffaella Scarpa [Nota sulla poesia di Furio Jesi, pp. 30-33], attenta alle implicazioni mitiche e simboliche e condivisibile soprattutto nell’individuazione di una radice comunitaria e aggregante nella concezione jesiana del mito, i cui linguaggi e concetti sono collettivi e oggettivi e costituiscono un pendant alla riflessione teorica dell’autore, difetta tuttavia la ricognizione della matrice rilkiana tra gli «antecedenti poetici che vanno da Ugo Foscolo a Ezra Pound» [p. 31], pure così evidente; forse proprio perché troppo evidente?).
Anche nella lettura rilkiana (nella lettura che Jesi offre di Rilke secondo il consuntivo di Margherita Cottone), comunque, la dimensione del mito è preponderante, a ribadire come questa tematica sia fondante di ogni moto conoscitivo dello studioso torinese. Così, Cottone sottolinea la continuità sostanziale, anche se non immediatamente evidente, nella lettura jesiana di Rilke da Germania segreta (1967) ai saggi di Esoterismo e linguaggio mitologico (1976) che ha il suo fulcro in un esoterismo necessario – quello del poeta che si fa «strumento cieco e puro di quella entità inconoscibile, di quella realtà misteriosa che muove la poesia» (p. 218) – ma che ribalta tale esoterismo da una dimensione estranea e anzi potenzialmente ostile all’umano a una collettiva che estende all’intera umanità la condivisione del segreto: un passaggio che in sostanza riflette la dinamica kerényana di «mito tecnicizzato/mito genuino», sancendo il ritorno a quest’ultimo dopo l’esposizione alle pericolose suggestioni del primo, e che corrisponde al percorso dalle prime Elegie, in cui è impossibile, come scrive Cottone riprendendo l’interpretazione di Jesi, «sottrarsi alle "immagini orride" di cui la figura dell’angelo è emblematica invocazione» (p. 220), alle ultime due che oppongono a tale orrore la dimensione compiutamente umana del dolore che apre la strada all’esperienza della morte. Di essa la controparte poetica è il silenzio: approdo finale dell’esperienza rilkiana che segna un peculiare «ritorno all’umano» (p. 224) nel segno – paradossale in quanto appunto silenziosa – di voce comune, di approdo, dopo un itinerario iniziatico disperatamente solitario, a un «noi» in cui «sono compresi anche tutti gli uomini che si riconoscono in un "sentire comune a tutti"» (p. 226). La scrittura sulla poesia, dunque, diviene per Jesi risposta alle esigenze che la stessa poesia pone, ovvero, come scrive Cottone, «la saggistica come maschera e strumento di difesa» che «si traduce in approccio al mito e a quanto di irrazionale in esso può esserci, sempre bilanciato da un bisogno di consapevolezza e difesa della ragione in grado di condurre verso quell’«‘equilibrio’ umanistico cui costantemente Jesi aspira» (p. 227).
Al mito, dunque, si finisce per ritornare anche nella riflessione sulle opere di più schietto carattere germanistico, e del resto è grazie a questo nucleo che scava nel profondo di un’esigenza diffusa e non soddisfatta delle appropriazioni del mito da parte della cultura di destra, ai suoi contributi per una definizione del mito che lo sottragga all’egemonia reazionaria e lo recuperi a una tradizione di diverso segno secondo un modello insieme illuministico e benjaminiano, che «Furio Jesi è divenuto, specialmente in questi ultimi anni, un autore di "culto"», come scrive Giulio Schiavoni nell’introduzione a un’altra recente impresa editoriale dedicata allo studioso torinese («La ceramica egizia» e altri scritti sull’Egitto e la Grecia [1956-1973], a cura di G. Schiavoni, Torino, Aragno, 2010; su di essa s’impernia il già rammentato contributo di Michele Cometa in questo «Riga» 31): un culto al quale paga pegno, oltre che l’idea stessa di questo volume, il testo che lo apre dopo il breve editoriale dei curatori e la cronologia della vita di Jesi, l’estratto da Trommeln in Genua di Wu Ming 1 (pp. 18-20). Si tratta di un brano che – in nome del caos frammentario e creativo, delle «schegge interreagenti» che secondo il metodo jesiano dovrebbero articolare la materia storica e ricomporla in quadro coerente per quanto di non immediata evidenza – coniuga il pensiero di Jesi con la più stretta attualità politica e lo inserisce in un meccanismo narrativo che attualizza in modo originale e sorprendente uno dei contributi più profondi e innovativi della sua riflessione sul mito: quello che riguarda la «macchina mitologica», usurpazione del mito che lo riduce a mero funzionamento meccanico, micidiale «congegno pericoloso sul piano ideologico e politico, anziché soltanto un modello gnoseologico provvisoriamente utile, quando ci si lascia ipnotizzare da essa» (F. Jesi, Mito, nuova edizione, con una nota di Giulio Schiavoni, Torino, Aragno, 2008, p. 154). Nel frammento di Wu Ming 1, a Genova, durante il tristemente noto G8 del 2001, a un protagonista ignaro e capitato lì per caso appare appunto, autonomizzatasi e divenuta reale, la macchina mitologica, incarnata in ciò che l’autore battezza «la rivolta degli sbirri», la «fine della normalità», il caos di coloro che, deputati a mantenere l’ordine, «all’improvviso violavano ogni legge e calpestavano le consuetudini recenti, gli accordi di piazza, la “minima decenza” di cui qualcuno avrebbe – inutilmente – parlato» (p. 18): il rovesciamento del mito in meccanismo autoalimentato e privato di un senso che non sia quello perverso dello sfruttamento del passato come guscio vuoto teso a legittimare un presente di oppressione. In uno scenario iperreale, percorso da fremiti di ribellione e rappresentato con lucido rigore visionario, non sorprende che possa apparire a un certo punto, sottratto alla dimensione della morte che la sua teoria avvertiva come superamento e non come limite, proprio Furio Jesi:
«Quel pomeriggio conobbi Furio, l’egittologo torinese. Fu il nostro primo e unico incontro, durante l’anabasi, nel cuore della rivolta. Di lui non ho più saputo nulla, svanì poco prima che giungessi in Piazza Alimonda. Mi girai per interpellarlo e all’improvviso non c’era più, risucchiato in un’altra dimensione. Forse, chissà, non è proprio mai esistito. Forse è stato allucinazione, miraggio, "amico immaginario". L’ho inventato per non sentirmi troppo solo? Eppure, nelle pause della fuga, quel ragazzo barbuto mi raccontò storie vere. Mi indicò, uno per uno, i fantasmi che marciavano in quelle strade. Mi spiegò in quale trappola fossero caduti i dimostranti, e come si era giunti a quel punto. Soltanto grazie a lui, al termine di quel venti di luglio, potei riconoscere la macchina; e quando la riconobbi, il motivo che mi aveva ricondotto in città era ormai spento, remoto come il fischio di un treno di cent’anni fa, ricacciato nel niente» (p. 20).
E’ proprio il testo di Wu Ming 1, alla fine, quello che, nell’immagine rovesciata di una camera oscura, più di tutti gli altri dà voce a quella sconvolgente capacità di Jesi «di pensare e progettare un tempo diverso e migliore rimanendo dentro questo» (Editoriale, p. 11), di tracciare il cammino da un «non qui, non ora» a un «qui, non ora» che abbraccia simultaneamente passato, presente e futuro.
E per concludere ricordiamo che, come avvisa una noticina in calce all’indice, «questo numero non finisce qui, ma continua su www.rigabooks.it con altri testi, interviste, recensioni…».
[Anno XIV, n. 33. Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici – Trento].