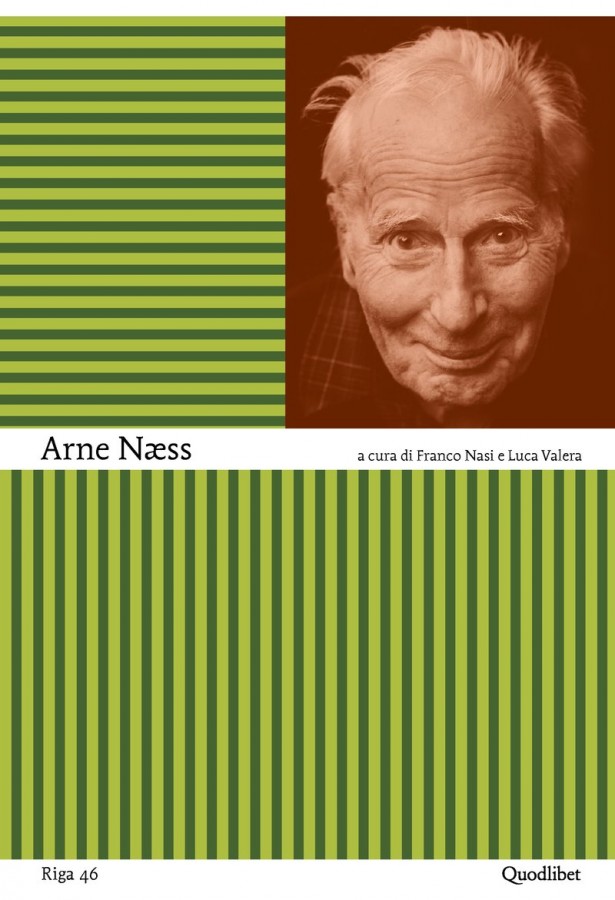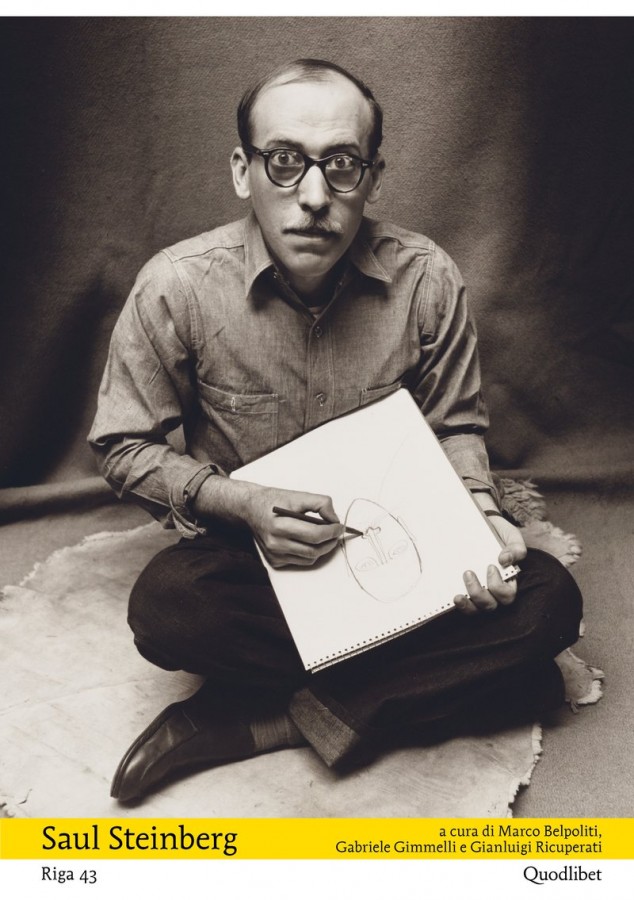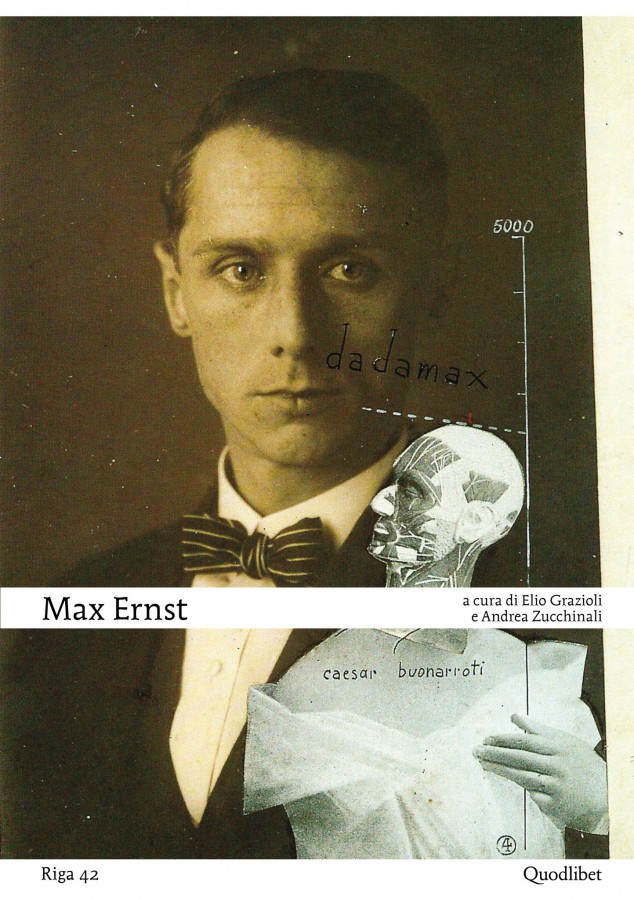Anna Panicali
Una rivista senza frontiere
Una rivista senza frontiere
«Il Menabò-Gulliver» esce nella primavera del ‘64 (anche se l’insieme dei testi era stato raccolto fin dall’inverno ‘62-’63) presso Einaudi e lo cura Francesco Leonetti. Finge d’essere un prolegomeno, invece è un esito e, per dirla con Enzensberger, “un segno del naufragio” di una grande idea: quella di una rivista e di una comunità internazionale.
Cos’era in gioco in esse? Uno spirito comune “magari in analogia ai tentativi di integrazione economica, alla formazione di assi politiche e di blocchi militari”? Così meditava la Bachmann tra sé e sé: “come se dovessimo fondare anche un supermarket dello spirito, solo perché è appena nato il Mercato comune, il supermarket Europa, e il burro europeo, le biciclette europee e i giocattoli di tutta l’Europa sono ormai a portata di mano...” .
Ma l’idea d’Europa degli scrittori coinvolti nell’ipotetica rivista internazionale non ha molto a vedere con discorsi di tipo economico, tecnico o pratico. Il progetto, come si è detto nella “Cronaca”, comincia a delinearsi in seguito a un evento politico: la guerra d’Algeria. Una guerra attorno alla quale ruotano due iniziative: «Le 14 Julliet», una rivista d’opposizione a De Gaulle che nel maggio del ‘58 si impadronì del potere e la Déclaration sur le droit à l’insoumission, stesa nel ‘60 e nota come il Manifesto dei 121 . Qui la politica si sposa col sogno comunitario e consente di esperire un modo d’essere insieme singolare. Agli occhi di Maurice Blanchot la sua singolarità risiede nella “forza impersonale” di un appello condiviso da tutti i firmatari. I quali hanno dato il loro nome, ma l’hanno spogliato dell’identità; l’hanno liberato dal peso sociale dell’io: “La dichiarazione ha rappresentato per loro una certa comunità anonima di nomi” . E quell’ossimoro - quell’anonimia di nomi - fa supporre che è stata messa in gioco l’autorità delle singole persone e addirittura il privilegio del soggetto . Anche la rivista internazionale che si sarebbe di lì a poco progettata, avrebbe chiesto ai suoi membri la rinuncia a ogni condizione di privilegio:
Costa una fatica ben più grande parlare ad amici e collaboratori distanziati, a un pubblico distanziato, lavorare in comune, quando occorre ancora uno sforzo per vedere la comunanza [...] - costa la rinuncia alla posizione dei singoli scrittori, che si presume solida ma che altrove potrebbe non apparire persuasiva, la rinuncia alle allusioni condizionate dall’idioma, la rinuncia al grado dei singoli scrittori, ai diritti derivanti dal grado.
La prima nozione cui ci troviamo di fronte in una lettera a Sartre di Blanchot, che di «Gulliver» fu il più appassionato promotore, è quella di comunità. Per i francesi la tradizione comunitaria affondava le radici molto indietro nel tempo: risaliva all’esperienza surrealista, quindi, a George Bataille e al misterioso controgruppo di Acéphale, la cui illusione era l’abbandono (“abbandono di e all’angoscia ultima che dà l’estasi”) vissuto in comune. Affascinato dalla sociologia che gli diede una conoscenza e insieme un senso nostalgico dei modi d’essere comunitari, Bataille si spinse lontano nell’esperienza della comunità, alla cui base intravvide un principio d’incompletezza. Blanchot, tornando a riflettere sull’argomento, si chiede: “perché comunità?” E come lui risponde: “Alla base di ogni essere esiste un principio di insufficienza”, la quale, a sua volta, fa appello alla contestazione che è sempre “esposizione a un altro (o all’altro)” .
I tedeschi avevano alle spalle l’appartenenza al Gruppo 47, che nel secondo dopoguerra riunì, in nome di un impegno etico, molti scrittori di lingua tedesca (tranne coloro che vivevano nella RDT): Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger.
In Vittorini, invece, la comunità si era connotata di valenze politico-allegoriche nel sogno del villaggio delle Donne di Messina del ‘49. Poi, negli anni cinquanta, il concetto si era caricato di senso operativo esprimendosi nel movimento di “Comunità” e della sua rivista e nel modo d’essere comunitario dell’azienda Olivetti, da cui restò fino agli ultimi anni affascinato.
Ma sono i francesi a elaborare un’idea teorica di comunità secondo il principio che “l’esistenza di ogni essere fa appello all’altro o a una pluralità d’altri” . Un comunità come forma dinamica: che fa leva sull’incompletezza e fa del processo la propria caratteristica strutturale. Una comunità “in vista della comunità”, per dirla con Blanchot: che prende forma nel suo stesso farsi e si offre come tensione sino a ipotizzare un movimento infinito. Tanto che Leonetti scherza sul pericolo di proiettare nel cielo dell’ideale sia la comunità sia la rivista: “Il bello è che è già una non-revue così com’è: invece di fare, si progetta e ci si convince a progettare [...]. I francesi sono da sforzare: in quanto per essi la vera rivista è ‘il movimento verso la rivista’” .
Nella Declaration la comunità era nata spontaneamente, da un evento. Così si sarebbe sviluppata nella rivista. Il filosofo polacco Kolakowski la definisce “genetica” e dice che rinvia a “un fatto, non a un programma”; che l’intesa è costituita da un atteggiamento intellettuale “nato da esperienze e crisi simili, benché vissute separatamente”; non dall’adesione a “una piattaforma ideologica” .
Ma l’aggettivo “genetica” rinvia anche a un sodalizio che si fonda su un dato spontaneo e naturale: non è forse il linguaggio e, nel nostro caso, la scrittura? Difatti, il fine di questa comunanza che si mantiene aperta alla ricerca e non fonda progetti o manifesti politici è di esprimersi in “una rivista di pensiero fatta da scrittori”. Senza dar peso al loro nome: ovvero, oltre la limitatezza del principio d’identità che li distingue. Sarà la scrittura, così pensano tutti i collaboratori, a garantire quell’anonimia di cui parla Blanchot, perché sfugge a qualsiasi forma di identificazione: “Cosa importa chi parla? - si domanderà qualche anno più tardi Foucault . Scrivere è perseguire soltanto il destino del linguaggio: giocare il nome, arrischiare la soggettività dell’autore, disfarsi dell’io per accedere all’anonimato di un’esperienza che non vuoi essere battezzata da alcuna attribuzione o proprietà”. Affermano i francesi che la scrittura sospende l’adesione in prima persona con il proprio discorso e spiazza qualsiasi ruolo: “Scrivere è entrare nell’affermazione della solitudine, dove incombe la fascinazione. È consegnarsi al rischio dell’assenza di tempo, dove regna l’eterno ricominciamento. È passare dall’Io all’Egli, di modo che ciò che mi avviene non avviene a nessuno, è anonimo” .
È a partire da questo spiazzamento e da questa cancellazione che si tenterà di mettere in scacco non solo l’identità individuale (l’autore) e collettiva (il gruppo), ma tutti i concetti su cui si fonda la storia dell’occidente: “l’idea di Dio, dell’Io, del Soggetto, quella della Verità e dell’Uno, quella del Libro e dell’Opera” ; che si tenterà di spezzare il sapere della totalità nel suo complesso. Quel sapere che aveva costruito le sue certezze sulla logica della continuità, la cultura dell’identico, il linguaggio delle risposte.
Nei primi anni sessanta l’Europa sta vivendo un trapasso epocale e, nell’inquietudine diffusa, si presentisce il cambiamento. Non essendo più rassicurati da alcuna risposta, si può solo dubitare delle certezze consolidate; offrire ipotesi anziché conclusioni; reagire interrogandosi e tentando di formulare nuovi concetti: “È il lavoro comune, lo sforzo di riflessione comune, di cui la rivista sarà il mezzo e l’affermazione concreta, che potrà, in una ricerca aperta e collettiva, offrire forse non delle conclusioni, ma un metodo critico nuovo, una nuova discussione”.
Se è vero che da solo “l’essere si chiude, si addormenta e si tranquillizza”, è altrettanto vero che l’intesa tra i collaboratori, non poggiando su un sistema di valori prestabilito, è sentita come una possibilità e la rivista “resta una scommessa su questa possibilità”. Perché, costituirsi in un collettivo vuoi dire mettere in moto un processo di comunanza; non darlo per scontato: “ciascuno, mettendo in comune i suoi sforzi, le sue domande, le sue risorse, attraverso il superamento interiore delle sue posizioni di pensiero, è condotto - per il fatto stesso che la rivista esiste - un po’ al di là o un po’ al di fuori del cammino che da solo avrebbe percorso, e diventa responsabile di asserzioni di cui non è l’unico autore o di una ricerca che non è soltanto sua”.
La strada verso una siffatta comunità non passa né per un collettivo di intellettuali che condividono una stessa fede, né per un’associazione cosmopolita di nazioni arroccate alla loro specificità (nel qual caso permarrebbero i particolarismi e il pensiero resterebbe confinato nei limiti del provincialismo nazionale). La comunità che informa il progetto «Gulliver» vuoi essere una comunità internazionale “in senso essenziale”. E ciò significa che
lo stesso sforzo di superamento richiesto individualmente da ciascuno deve essere compiuto, in proporzione, da ogni gruppo nazionale. Mettendo in comune i problemi letterari, filosofici, politici, sociali, così come si pongono nel contesto di ciascun paese e di ciascuna lingua, ognuno rinuncia a un diritto esclusivo di valutazione dei propri problemi e riconosce che questi appartengono anche agli altri. Non si tratta di privare della loro specificità i problemi propri di quella regione del mondo ma, al contrario, di coglierne la specificità in quanto tocca la questione generale
Significa cioè che l’idea stessa di comunità internazionale esige di guardare con uno stesso colpo d’occhio sia all’identità che alle differenze; sia ai problemi specifici che generali. O meglio, esige di pensare alle diversità nell’unità europea.
Siamo a una svolta che non consente più di ripercorrere le vecchie strade: “qualcosa di decisivo accade e cerca di affermarsi” e quest’inizio non può iscriversi nel solito scenario di riviste “senza necessità”.
A Sartre che guarda ancora a «Les Temps Modernes», Blanchot scrive: “Io credo che se vogliamo rappresentare come si deve, senza equivoci, il cambiamento che abbiamo reciprocamente presentito, se vogliamo renderlo più concreto e approfondirlo, nella sua inafferrabile presenza, nella sua nuova verità, potremo farlo solamente a partire da un organo nuovo” .
Che non può essere una rivista di cultura: congelata ormai in un “genere”, enciclopedica, e perdipiù con un’identità ideologica. Né un collettivo fondato sulle affinità - letterarie, politiche o culturali - delle nazioni coinvolte. Una rivista che si fondasse su elementi affini:
non avrebbe mai potuto avere una struttura sua propria, nuova per tutti, e unitaria:unitariamente nuova [...].Ogni gruppo vi avrebbe conservato, grazie alla mancanza di attrito data dalla certezza tranquillizzante dell’affinità, la sua vecchia struttura di gruppo nazionale, col suo particolare colore nazionale; e non si sarebbe avuta, alla fine, che una sovrapposizione di tre volte la stessa struttura, ma in tre diverse accezioni, tre diversi colori che mai avrebbero potuto fondersi in un unico colore nuovo.
In questo modo non ci sarebbero stati né comunanza né dialogo e sarebbe sortita una rivista “di pura e semplice omologazione. Ovvia”. L’unità verrà fuori “attraverso l’ingranarsi non di risapute affinità più o meno sovrapponibili, e in ultimo sterili, ma di difformità reciprocamente provocatorie”, scrive Vittorini’ . E i francesi aggiungono che la comunicazione si sarebbe instaurata a partire non da un’intesa ma da una dissimmetria.
È subito chiaro che si va facendo strada un nuovo concetto. Le parole perdono il senso che la lingua abituale ha loro conferito e mettono in gioco un’idea di dialogo estranea alla pacifica composizione. Il dialogo è pensato come una via che passa per la differenza. Difatti, se il pensiero è domanda, non può non essere confronto di alterità e con l’alterità: abbandono di un unico senso, di un unico orizzonte, di una risposta unica e definitiva e ricerca invece di una parola plurale, che unisce nella separazione. Si chiederà più tardi Blanchot: “Come può affermarsi la ricerca di una parola plurale fondata non più sull’uguaglianza, non più sul predominio e la subordinazione, non sulla mutualità reciproca, ma sulla dissimmetria e l’irreversibilità, in modo che tra due parole esista sempre un implicito rapporto d’infinità che sia come il movimento del significato stesso?”.
Sono i francesi che, riflettendo sul concetto di differenza, approdano a una nozione non dialettica di dialogo. Mascolo medita in termini paradossali sui folli di un ospedale psichiatrico, in contatto diretto fra loro e tuttavia ignoti gli uni agli altri, “alterità pura”:
Comunicazione da ferita a ferita, da dolore incomunicabile a dolore incomunicabile, da solitudine a solitudine: un segreto proferito collettivamente. Niente di simile a un dialogo. Nessun impiego della parola che tenda a restringere l’abisso della differenza. Il senso di una simile società sta nella presenza di un principio nuovo, che non appartiene propriamente a un ordine poetico, né propriamente a quello della carità, ma forse consiste in una carità poetica. E la figura pregnante di un comunismo meta-fisico. Permanendo fino in fondo la separazione, le differenze inessenziali sono sop-presse. E così si spiega che il dialogo come confronto “pacifico”, correttivo idealistico alla guerra dei prestigi, alla competizione mercantile, e alle loro conseguenze - il dialogo caro agli umanisti - sia diventato inutile
Lo stesso concetto è espresso da Blanchot nell’Infinito intrattenimento: il dialogo nasce dalla separazione, non da un accordo. E anche Barthes smaschera l’utopia liberale che lo vuole come “luogo d’incontro di due buone volontà” .
Dunque, se il dialogo fa leva sulla differenza, una rivista che non voglia essere “di pura e semplice omologazione” è tutta da inventare. Uno dei compiti, ripete Mascolo, “è l’elaborazione della rivista come forma da scoprire e la messa in opera di tale forma” . E prefigura con le sue parole anche un concetto di comunità del tutto nuovo: in cui la scrittura stessa che ne sta alla base è uno “spazio d’interrogazione”.
Non per caso, il senso e la necessità del domandare sono all’origine della differenza fra una rivista di cultura e una rivista letteraria:
Oggi, al punto in cui siamo, dopo Marx e dopo Lenin, la cosa difficile non è rispondere, è interrogare, è parlare interrogando. Ecco perché possiamo apparire meno uomini di cultura dei nostri partners: perché siamo consapevoli, quasi in modo esagerato, dello scarto che esiste tra l’affermazione culturale e l’affermazione artistica o letteraria; consapevoli anche che questo scarto rappresenta ciò che precisamente sfugge a ogni processo di unificazione.
È così che scrittori di più paesi, diversi per tradizione, lingua e cultura si uniscono insieme per una comune abitudine intellettuale a interrogarsi, a mettersi in questione. E il loro legame, anziché sopprimere, esalterà le differenze perché si fonda sulla scrittura, che è il segno più emblematico della solitudine e dell’alterità.
La verità della scrittura
Può capitare che una testimonianza esistenziale o politica prenda forma di letteratura; che un’opera finisca per rivelare una “verità sotterranea” e iscriversi nella memoria degli uomini: nella storia. In tal caso svolge, attraverso il lavoro solitario dello scrittore, un compito di “politica indiretta”. Perché c’è sempre uno iato fra la realtà e la presa letteraria su di essa. Come nel romanzo di Uwe Johnson su Berlino: “Forse il lettore e il critico frettolosi potranno dire che, in opere di questo tipo, il rapporto col mondo e con la responsabilità di una decisione politica nei confronti di esso resta lontano e indiretto. Indiretto, sì. Ma c’è appunto da chiedersi se, per aderire al mondo con la parola e soprattutto con la scrittura, una via indiretta non sia la via giusta, e anche la più breve” .
Quando lo scrittore parla “in quanto scrittore e nella prospettiva che gli è propria”, si assume la responsabilità che “gli deriva dalla sua verità di scrittore”. Una verità che corrisponde alla sua “più intima ragion d’essere” e si sottrae al rischio autoritario perché ha origine dal dubbio. Una responsabilità del tutto diversa da quella che, a partire dal ‘45, ha “brutalmente” marcato i rapporti fra letteratura e vita. Il tempo dell’engagement sartriano si è concluso: al vecchio impegno, ch’era “di parte” o di partito, si sostituisce un dovere etico “impersonale”; a un mandato che investe l’individuo e risponde della parola in prima persona, si sostituisce la responsabilità dello scrivere, che va al di là del soggetto. Una responsabilità anonima, oltre il singolo autore o il singolo paese: “La rivista deve rappresentare nella vita intellettuale, politica e letteraria una certa forma di responsabilità e, attraverso essa, affermare un’autorità intellettuale che non è né l’autorità di una persona né di un gruppo, ma corrisponde all’esigenza impersonale della ricerca letteraria e filosofica. E non è data in partenza, ma si svolge col movimento di pensiero che la rivista produce” .
Un concetto difficile, quello dell’autorità intellettuale da conquistare col tempo: s’impernia sulla struttura della rivista come movimento d’insieme e i francesi vi insistono fino all’ultimo anche se, forse, è stato concepito un po’ astrattamente e ha finito per provocare una “rottura rovinosa”. Ma nelle intenzioni di Blanchot era chiaro: “se la direzione internazionale non può essere esercitata in modo autoritario direttamente sul contenuto dei testi (e sarebbe possibile solo se la rivista pretendesse d’incarnare un’ideologia), essa tuttavia può e deve esercitarsi sulla struttura, la forma, la coerenza e il movimento d’insieme di ogni numero. Struttura che custodirà il senso ultimo della nostra impresa e le sue possibilità di futuro” .
Si è parlato di scrittura come luogo di responsabilità (solo più tardi Barthes introdurrà il postulato del luogo di godimento e di piacere). Si tratta di una responsabilità nuova, epocale: della scrittura di fronte al pensiero. Al pensiero e non alla filosofia. Scrivere comporta “una tremenda responsabilità”: presuppone “un radicale cambiamento d’epoca - la morte stessa, l’interruzione - o, per usare un’espressione iperbolica, la fine della storia . E poiché la storia che l’occidente ha conosciuto è improntata all’idea di continuità e di progresso, l’iperbole suona come liberazione dalla dialettica e da tutte le rappresentazioni di cui l’uomo è ancora prigioniero. Di qui l’insistenza dei francesi sulla discontinuità e sul frammento che la raffigura: “oggi la discontinuità è l’essenza stessa del mondo. Quasi che si trattasse per noi di edificare un mondo - l’universo, l’affermazione più totale, più unificata - proprio sul carattere disarticolato, disarmonico, frantumato dell’essere, o sulle carenze dell’uomo” .
La letteratura
La rivista si qualifica soprattutto per il suo carattere letterario, ma qual è l’idea di letteratura che coltiva? Finora la letteratura era stata pensata soprattutto come veicolo di contenuti; al di fuori del linguaggio. E l’opera letteraria si era messa in rapporto con la società, la storia o l’estetica. I primi a postularla come un linguaggio sono stati i francesi e proprio in un momento in cui l’ideologia ancora trionfante era quella della rappresentazione. Quel che oggi sembra naturale, confessa Roland Barthes, “ha dovuto essere conquistato”. Allora, definire la letteratura un linguaggio parve una provocazione di carattere formale: sembrò quasi si volesse negare il suo potere “realista (protetto dall’alibi sociale e, in certi casi, socialista)” . In realtà, in questa sua nuova veste era un terreno vergine. Diceva, sempre Barthes agli inizi del ‘60: “Stiamo uscendo da un momento, quello della letteratura impegnata. La fine del romanzo sartriano, l’imperturbabile indigenza del romanzo socialista, la carenza del teatro politico, tutto questo, come un’onda che rifluisca, lascia scoperto un oggetto singolare e singolarmente resistente: la letteratura” . E pensava alla letteratura come esperienza del linguaggio e ricerca interminabile del senso. Ma il linguaggio è ambiguo, contraddittorio e la sua doppiezza è strettamente legata al rapporto con l’altro. Per i francesi, e in particolare per Blanchot, è proprio la scrittura a farci sentire, nel linguaggio, una relazione di alterità radicale, assoluta. E non è un caso che in «Gulliver» la letteratura diventi sinonimo di écriture e le si accordi una duplice valenza: interrogativa e di ricerca. Perché il senso della vita, forse consiste in un interrogarsi privo di risposta o, in altri termini, la dimensione più propria del linguaggio è quella di “porre domande reali, domande totali” . Domande che rifiutano il principio stesso del dominio, dato che il linguaggio, si sa, è per eccellenza potere e ci getta nella dialettica del servo e del padrone:
Bisogna tentare di riafferrare nell’opera letteraria il luogo dove il linguaggio è ancora relazione senza potere, linguaggio del rapporto nudo, estraneo a ogni padroneggiare e a ogni servire, linguaggio inoltre che solo parla a chi non parla per avere e per potere, per sapere e per possedere, per diventare padrone e padroneggiarsi, cioè a un uomo assai poco uomo. E certamente una ricerca difficile, benché noi siamo, con la poesia e l’esperienza poetica, sulla linea di questa ricerca
.
Se la letteratura era pensata come altro da sé, come strumento immediata-mente politico, ora è pensata come un’esperienza critica globale che sottopone a revisione tutti i campi della vita. Si dice: perché la parola “critica” ritrovi il suo senso, è necessario si estenda a ogni aspetto dell’esistenza. Sarà l’intera realtà a essere criticata, e questa critica, ripete Enzensberger, “sarà fatta da scrittori”. Non basta la critica della cultura, che “pretende di mettere in questione in modo idealista l’esistente, come se non ne facesse parte . Così Mascolo: “La letteratura costituisce un’esperienza radicale, fondamentale, perché mette in questione tutto, compreso se stessa. Non essendo unicamente affermazione delle opere, ma ricerca di sé, contestandosi essa stessa e conte-stando al contempo tutte le altre forme di potere, non deve essere sottomessa ad alcuna restrizione, ad alcuna sorveglianza dogmatica” .
Contesterà il potere, la dialettica con la sua idea di progresso, se stessa. E rifiuterà ogni barriera: lo specialismo, le frontiere della civiltà (“non esistono regioni particolari”, avverte la Bachmann), la separazione tra le discipline e fra scritti critici e creativi. Più volte in «Gulliver» si ripete che non deve esserci divisione fra l’antologia dei testi e la parte saggistica; che critica e invenzione si metamorfosano l’una nell’altra; che qualsiasi problema verrà affrontato dallo scrittore e non dagli specialisti. D’altro canto, se torniamo all’espressione “rivi-sta di pensiero fatta da scrittori”, ci accorgiamo che la scrittura, lungi dal separare invenzione e teoria, è intesa come un atto di pensiero risolto in linguaggio. Che, rispetto ai vari linguaggi, dal politico al matematico, ha “il vantaggio d’essere l’unico globale. Tutti gli altri linguaggi culturali sono separatisti. Solo quello letterario è unitario”, dice Vittorini. E aggiunge che avrà il vantaggio sulla lingua parlata “(per natura convenzionale e approssimativa) di tendere alla precisione (come dimostrano le sue stesse possibilità figurative)” . Ma si tratta di un’unità che vive delle differenze e che fa della domanda la sua stessa essenza. Perché, a sentire Blanchot, viviamo un grande cambiamento: siamo passati dall’epoca della filosofia come sapere della totalità a quella della letteratura come pensiero della differenza. Ed è proprio la scrittura il luogo dove prende forma un pensiero che pensa ciò che è oltre la totalità, oltre la filosofia. L’inaugura l’epoca in cui tutti i concetti della cultura dell’occidente s’inverano e, insieme, rischiano di tramontare. Con le sue stesse parole: “Noi apparteniamo alla fine della filosofia, fine necessariamente ambigua [...] che, in quanto fine, non finisce affatto, può durare lunghe epoche storiche, ma che, come tale, ci investe di compiti radicalmente altri, ai quali non corrispondono più le vecchie etichette”. Quel tempo vien chiamato “comunismo”, ma è solo un nome. Con l’abolizione della vecchia società divisa e con l’avvento di un mondo politicamente, socialmente e culturalmente unificato, sembra raggiunto il fine della metafisica occidentale (e della tradizione dialettica): ricondurre tutto sotto il dominio del concetto. Ma la realizzazione pratica di questo fine rischia di coincidere con la fine della filosofia. Solo il linguaggio può raccogliere la sfida, interrogandosi e guardando all’unità come al limite al di là del quale si estende il territorio sconosciuto di un pensiero che pensa il mondo non più nella sua totalità, ma nella sua differenza:
In quanto scrittori siamo già nel comunismo, ed essendoci, la risposta è data: è la risposta dell’unità comunista. Ma, a partire di qui, a partire dal momento in cui ciò che si richiede alla parola è d’essere qualcosa d’altro che una risposta, da questo momento comincia ad affermarsi l’esigenza propria di ogni linguaggio letterario: quella d’essere essenzialmente domanda, l’interrogazione radicale che non è detto l’uomo possa sostenere, allo stesso modo in cui non è detto ch’egli sia capace di letteratura.
La parola frammentaria
I concetti teorici che informano il progetto di rivista e di comunità internazionale vengono elaborati soprattutto dai francesi. E sarà sempre il loro gruppo così “omogeneo” rispetto al tedesco e all’italiano, a proporre una rubrica attorno alla quale la revue dovrebbe ruotare e organizzarsi. Il suo nome, Cours des choses, accenna al farsi delle cose, a una realtà in divenire, cui corrisponde l’idea stessa di una comunità in movimento. Ma è proprio su questa rubrica che rivista e comunità si romperanno. Soprattutto perché si affida alla “parola frammentaria”: una scrittura di brani fra loro fortemente discontinui, ancora insolita al pensiero europeo.
È vero che il Cours si presenta come un luogo di sperimentazione e di ricerca, tuttavia la scrittura per frammenti sconcerta le abitudini tedesche e italiane legate ancora al genere saggistico. Per i francesi la “forme courte” non risponde a un semplice mutamento di valori retorici, ma è l’espressione dello scacco del linguaggio: dice la perdita della totalità, la separazione, l’assenza di un fondamento. Ed è elevata a principio non tanto estetico quanto ontologico: “Ciascuno, dal momento che non è più saldato al tutto (dal momento che questa illusione di essere saldato al tutto gli è stata tolta), sembra essere ridotto a niente più che un frammento, fra tanti, di un insieme scomparso” .
A differenza del saggio che è una forma espressiva in sé conclusa, la scrittura per frammenti lascia intuire che non tutto è detto; che il linguaggio non è più soggetto a una forma unitaria ed esaustiva; che ha perduto ogni riferimento e ogni illusione di totalità. Così i francesi ripeteranno agli altri gruppi nel loro Memorandum: “Ciascun testo non solo sarà breve [...], ma costituirà come un frammento, che non esaurisce necessariamente tutto il suo senso in se stesso, ma si apre su un senso più generale ancora a venire” .
Col titolo dell’ultima raccolta poetica di René Char, Blanchot chiamerà “parola in arcipelago” questa nuova figura della dispersione del linguaggio che sfugge alle insidie del continuum e libera il pensiero dall’essere pensiero solamente in vista dell’unità; che non tollera alcun riferimento né a un centro né a un’origine, senza alcuna garanzia, si espone al rischio dell’impensabile e del silenzio. Non è uno stile fra gli altri, ma una forma sostanziale. Anzi, per i francesi è la sola forma della scrittura , perché l’unica che possa render conto di uni domanda ininterrotta.
La scelta deliberata del frammento “non è ripiegamento scettico, stanca rinuncia t una sintesi completa (potrebbe esserlo): ma un metodo paziente-impaziente, mobile-immobile di ricerca, e l’affermazione - inoltre - che il servo, l’integrità del senso non può trovarsi immediatamente in noi e in ciò che noi scriviamo, ma che è ancora a venire e che, interrogando il senso, noi lo costiamo come puro divenire e avvenire interrogativo» .
l testi frammentari non vanno letti isolatamente perché il loro significato dipende dal rapporto che istituiscono con tutti gli altri scritti. I quali sono legati fa loro dal bisogno di leggere il mondo attraverso una pluralità di voci e di riflessioni. Ma occorre armonizzarli in una struttura generale, impedendo che “la rivista rischi di disperdersi nell’informe, come accadrebbe se la diversità di questi testi molteplici non si componesse e non si articolasse in un progetto d’insieme” .
Blanchot fa eco Barthes che ipotizza “una dispersione concertata di frammenti, di figure, di parole” . D’altro canto, non si dimentichi, l’avventura detto strutturalismo iniziava in quegli anni il suo cammino. Barthes considerava il frammento “una unità strutturale” che esiste soltanto “in rapporto ad alte unità” e aggiungeva: “il frammento non ha senso in sé, ma è tale tuttavia che la minima variazione apportata alla sua configurazione provoca un cambiamento dell’insieme” .
La “forme courte” - nel senso “che si dà a questo termine nella musica d’oggi” - annuncia un’esperienza non dialettica: fa parlare la discontinuità e l’intermittenza; smaglia il discorso coerente e sistematico; spezza la logica che confida nella verità da dimostrare e illuminare “a giorno” ; esprime il pensiero della domanda. Solo la domanda, infatti, rompe la violenza dell’unità e del sistema in cui si esercita il potere del logos.
Anche il problema della divisione di Berlino è formulato da Blanchot frammentariamente: perché è impossibile abbracciare in un unico sguardo la sua realtà completa o parlarne in termini che si presumano esaustivi. Il suo senso può essere solo interrogato ed espresso per approssimazioni, per aggiunte, per continue domande: “Fino al 13 agosto 1961, l’assenza di un segno di separazione visibile - anche se una serie di controlli regolari e irregolari faceva sentire l’approssimarsi enigmatico di una linea di demarcazione - dava alla spartizione un carattere e un significato ambigui: che cosa era? Un confine? Certamente: però anche qualcosa d’altro; meno di un confine, visto che ogni giorno lo si poteva varcare in massa sfuggendo al controllo, ma anche assai di più, poiché varcarlo era passare non già da un paese a un altro, da una lingua a un’altra, ma, entro il medesimo paese e la medesima lingua, dalla “verità” all’‘errore’, dal ‘male’ al ‘bene’, dalla ‘vita’ alla ‘morte’” .
Come la comunità, anche il frammento nasce da una incompletezza. Se il saggio circoscrive l’oggetto di cui parla e conclude, il frammento annuncia una relazione d’apertura: senza illudersi d’esaurire il discorso, provoca, interroga, si prolunga nella riflessione che segue e trova il suo senso nel rapporto con tutti gli altri frammenti che si presuppongono e si rinviano reciprocamente.
È così che il Cours - composto di testi frammentari - diventa metafora del legame che si tesse fra uno scritto e l’altro, e quindi, del colloquio fra i diversi interlocutori. Metafora di un’unione e di una comunità, che non è data a priori né si compie una volta per tutte, ma diviene e si fa nel movimento interrogativo e dialogico. Metafora, infine, di una rivista che è alla ricerca della propria forma e del proprio “tono”, per dirla con la Bachmann, e li troverà se saprà articolare e comporre la pluralità dei diversi pensieri, dei diversi frammenti in un’architettura, senza che “l’insieme significativo” cui ogni numero darà vita, s’imperni su un tema o sul contenuto del discorso.
I numeri “formeranno un tutto senza essere dei numeri monotematici’ - si ripete nei Testi preliminari. O ancora: “Il mondo non è tematizzabile”. Ed è per questo che i francesi rifiuteranno il tentativo vittoriniano di compilare delle schede con argomenti sui quali interpellare gli scrittori e insisteranno sul fatto che il senso del Cours, cardine della rivista, “deve svelarsi e manifestarsi” attraverso la sua forma.
Le schede, se da un lato soddisfano l’esigenza di non casualità e acconsentono a una struttura, a una forma , dall’altro, sono soltanto espedienti che forzano l’interesse dell’autore senza minimamente provocarlo. Perché è la differenza di più punti di vista che provoca e spinge al confronto.
La differenza
La rivista, si è ripetuto più volte, si sarebbe fondata sul confronto e la loro vocazione fra “tendenze letterarie molto diverse l’una dall’altra”, perché solo così avrebbe potuto dar vita a un nuovo legame. Ovvero, a una comunanza e a un’unità nuova: che accetta la disgiunzione e la divergenza e, anzi, fa leve su esse. Purtroppo però l’internazionalità rimase un’utopia e le differenze, sia letterarie sia politiche, generarono un costante malessere fra i gruppi. Nel uso dei tedeschi, al marchio nazista si aggiunge, nel presente, la divisione di Berlino che arriva a compromettere persino l’identità nazionale. Il rapporto che la Germania coltiva col passato costituisce un peso insopportabile da rimuovere: “I ragazzi del gruppo tedesco sembrano considerare che la politica culminata nel nazismo ha privato di ogni validità di tradizione positiva gotto quello che è stato detto in Germania da Goethe in poi; sicché anche le parole che noi o i francesi o non so chi altri possiamo ancora tenere per fondamentali da Hegel sono per loro infide, pericolose” .
E un peso che mina l’internazionalità della rivista perché porta a voler ricostruire un’identità nazionale di cui non vergognarsi e a privilegiarla. La Germania, su cui sembra gravi un senso di colpa storico-epocale - come un complesso di persecuzione “etnica” - vive una condizione di vero e proprio sgretolamento: etico, linguistico, politico. Il nazismo e la costruzione del miro che divide Berlino sono sentiti come una ferita che attraversa il popolo.
Ripetono i francesi: “Non si tratta di privare della loro specificità i problemi propri di una regione del mondo ma, al contrario, di coglierne la specificità in quanto tocca la questione generale” . Tuttavia il muro di Berlino isola i tedeschi in una loro specifica differenza e rimette continuamente in gioco la loro partecipazione al progetto: “Berlino puzza di guerra e di paura [...]. Per me non è un fatto di cronaca ma un evento capitale”, grida Enzensberger . E allora? come lavorare serenamente a una comunità europea? Mentre Mascolo, ostinato, ripete che la responsabilità sarà internazionale (“non ci sono né direttori né comitati di direzione nazionali”), i tedeschi avvertono l’urgenza di un organo di stampa, ma preferiscono un mensile tedesco a una rivista a direzione collettiva. D’altra parte, essendo ormai divisi in due entità incomunicabili fra loro, cosa può significare “pensare in europeo” se non si sa neppure cosa significhi “pensare in tedesco”? La Bachmann vuol scoprire la propria identità nazionale, prima di pensare a una comunità internazionale. Non abbiamo “voglia di allearci nel modo corrente”, dice, perché “ci manca ancora tanta comprensione di noi stessi, una comprensione nuova, asentimentale, che non è ancora del tutto possibile” . Il concetto che la guida è che comunicare con l’altro è un’occasione per conoscere meglio se stessi e i problemi della propria nazione. Formare un “triangolo” francese, italiano, tedesco, è auspicabile sol-tanto se serve a parlare “in maniera un po’ diversa per diventare più esatti nella rappresentazione di se stessi, e per rappresentarsi con una maggiore esattezza gli oggetti nella loro scala d’importanza”; se possiamo esercitarci a parlare delle nostre cose, “mentre di solito è difficile farlo nel proprio paese”: “Infatti, quando parliamo nella nostra lingua ai nostri connazionali, siamo tutti tentati di fare assegnamento sull’ovvietà familiare, di trattenerci nell’intimità storicopolitico-culturale (perfino con i nostri avversari), ad appoggiarci comodamente a presupposti che non è più necessario verificare” .
Questa giusta spinta a comunicare e ad intendersi tra nazioni diverse può essere strumentalizzata però dalla vacua propaganda europeista della riconciliazione, dietro la quale si nascondono concreti interessi economici d’unificazione e d’espansione dei mercati: se prima si strumentalizzava il conflitto, oggi si strumentalizza l’ingenuo desiderio dei popoli di abbandonarsi “dopo tanto odio manovrato, a un amore altrettanto manovrato”. Dunque è necessario appellarsi alla ragione: per comunicare autenticamente con l’altro non servo-no gli ipocriti appelli solidaristici, ma una piena consapevolezza della propria identità: “Pensare in europeo? Chi non si sentirebbe imbarazzato, dal momento che, per esempio, non sappiamo neppure che significa pensare in tedesco o in austriaco, e non vorremmo neppure saperlo o farcelo dire, perché non ce ne ripromettiamo niente di buono” .
Non potrebbero esserci parole più attuali, oggi che alla retorica europeista si è aggiunta l’altrettanto vacua retorica della multicultura e dell’integrazione con il diverso, il cui concetto si rivela tanto vuoto quanto è stato radicale l’annientamento che abbiamo compiuto delle culture altre nei loro luoghi di origine, privandole di ogni memoria e identità, sì che non resta loro che l’ossessivo desiderio di assimilarsi e di identificarsi con i modelli più convulsi del nostro modo di vivere.
Tutti gli articoli dell’équipe tedesca apparsi sul «Menabò» n. 7 testimoniano l’urgenza di ridefinire l’identità nazionale. La Germania, dice Uwe Johnson, non è più una nazione: né in senso geografico (perché non ha una capitale), né in senso storico (perché non ha un passato cui riferirsi). E diventata una provincia ed entrambe le zone in cui è stata divisa sono asservite all’interesse di parte. Ma, “così come i resti del territorio statale tedesco, divisi sono anche i modi di vita” e gli scrittori dei due paesi:
Già prima della totale abolizione della libertà di spostamento, nel migliore dei casi, agli emigranti era possibile mantenere nella memoria e nel sentimento sia la situazione abbandonata sia quella scelta, e quando, per le premure dedicate all’una, la coscienza dell’altra non si spezzava immediatamente, di lì a poco tempo essi erano ignorati quanto gli scrittori locali, per i quali l’altra terra era sempre stata, fin dall’inizio, più lontana che non la Polonia o l’Algeria, e ciò, appunto, non soltanto per ragioni di pericolo politico.
Neppure sul piano linguistico la Germania riesce a essere una nazione. Sebbene la lingua sia l’elemento comune, paradossalmente gli scrittori occidentali e orientali non riescono a parlarsi. L’estraneità degli uni agli altri impedisce qualsiasi intesa e anzi li distanzia e li induce in errore: “deforma perfino il comportamento reciproco degli scrittori dei due paesi, quando per esempio in occasione della costruzione di un muro di sbarramento attraverso Berlino e della posa di mine lungo la linea di demarcazione attraverso il territorio tedesco scrittori occidentali invitano i loro colleghi orientali a unirsi alla protesta contro le misure del governo comunista, e agiscono per così dire in modo intertedesco” .
Parole e concetti come, ad esempio, “progresso, sinistra borghese” o “reazione” suonano in modo diverso nei due paesi; ingenerano equivoci che avviliscono la lingua; creano addirittura “avversari per malinteso”:
Gli scrittori di entrambi i paesi si sono lasciati allineare, identificandosi, o lasciando-si identificare con gli interessi politici del governo del paese in cui abitavano, o perlomeno rendendo gli interessi dell’altro governo definizione negativa del proprio atteggiamento. Questi antagonisti, che stanno dalle due parti e che insultano, denunciano, svergognano, ignorano gli altri, come se uno scrittore fosse responsabile di tutti i particolari del suo paese, dai mezzi di trasporto fino alla verniciatura delle cassette per le lettere, più di un altro cittadino, questi avversari per malinteso e per caso avviliscono ciò che hanno in comune e ciò che potrebbe costituire la loro misura: la loro lingua e l’uso che ne va fatto.
Le parole sono segni, ci dice Martin Walser, e se tornano alla mente alcune frasi vuoi dire che alludono a qualcosa che non riusciamo a cancellare o a allontanare da noi: “Di chi è la colpa, se già dal mattino presto la lingua mi passa come in un gioco queste quattro parole? La crocifissione di un gatto . E della lingua? Ma “la lingua [...] non esiste’. O meglio, “è quello che sono io stesso”: cresce con me, “indistinguibile da me. Giacché il luogo della lingua è la memoria. Che è fatta della stessa materia della storia”. Se “la crocifissione di un gatto” mi rimbalza nella mente, forse vuoi dire che mi lancia “un segnale, quasi una specie di ordine”. Mi chiede di risalire al passato: “Quello che è accaduto, viene custodito nella lingua, nella memoria, nella storia, in me, in tutti: bisogna aspettarsi che la lingua ce lo ricordi, anche se si preferirebbe dimenticarlo” .
È la lingua che richiama in vita il passato. E la lingua tedesca è doppiamente ferita: sia dal nazismo, sia dal presente. Liberarsi dalla colpa contribuisce “alla nostra salute spirituale”, ha affermato recentemente Kolakowski, tornando sull’idea della responsabilità collettiva: “Noi non siamo personalmente responsabili per i nostri predecessori: ma se crediamo nel fatto che una nazione sia un insieme spirituale e morale che mantiene nel tempo la sua identità malgrado le generazioni che muoiono e le nuove che le sostituiscono, è giusto credere che accanto alla responsabilità singola esista anche quella collettiva, cioè quella della nazione come continuità” .
Si è parlato di un’unità nuova che i francesi pensavano come figura “di un comunismo metafisico”. Un’unità plurale, fondata sulla letteratura, in cui le differenze non solo non vengono soppresse ma costituiscono la condizione della sua possibilità:
Forse uno dei malintesi che ci agitano viene di qui: i nostri testi potrebbero apparire reazionari a coloro che si ostinano a leggerli nella prospettiva pre-unitaria, mentre per noi rappresentano un approccio alla questione fin d’ora aperta, in quanto appartengono alla `fine della filosofia’. Tutto accade come se bisognasse sempre pensare - dire - il mondo due volte, una prima volta nella prospettiva dell’unità e in rapporto all’avvento del tutto, una seconda volta nell’affermazione della differenza e dell’esigenza della discontinuità
Ma è proprio la diversa idea di letteratura ad alimentare malintesi diffidenze sospetti. E sono i francesi che si distinguono dagli altri due gruppi, tanto da far nascere equivoci e da venir continuamente fraintesi. Italiani e tedeschi li accusano di non volersi misurare con le cose , mentre per loro l’unica realtà dello scrittore è la letteratura; l’unica verità da ricercare è la verità della parola; l’unica cosa di cui occuparsi è il linguaggio. Italiani e tedeschi sembrano ancora prigionieri del ricatto del realismo e del rappresentare , mentre i francesi, se si rifiutano al racconto , è perché vogliono uscire dalla scena della rappresentazione; se elaborano la nozione di frammento è perché vi intravedono la sola forma che tangibilmente la nega . La loro scelta è anche una proposta politica: perché il frammento è la voce della differenza e della pluralità e, a un tempo, nega la dialettica e lo storicismo che stabilisce un continuum fra il passato e il futuro. Purtroppo, neppure Vittorini, per quanto si senta alieno dalla dialettica hegeliana, capisce fino in fondo il senso della scrittura per frammenti e nella lettera a des Forèts del 26 gennaio 1963 ne parla come di una forma o di uno stile individuale, caratteristico solo di alcuni scrittori. L’incomprensione fra i gruppi si fa esplicita nel giudizio di Bochlich sul lavoro dei francesi (il loro orientamento è “privo di riferimenti”) e nelle parole accorate di Blanchot, cui sembra di vedere di colpo tornati i vecchi fantasmi: “È arrivato a criticare i nostri testi come un critico della cultura e un ideologo. Un modo che ci sembra pericoloso, perché giudica l’atto letterario sulla base di criteri estetici e ideologici impliciti cui, a nostro avviso, non si possono sottomettere i testi degli scrittori. Per me, l’atto o l’esperienza letteraria è indivisibile: si accetta o si rifiuta per intero” .
Il giudizio di Boehlich, redattore della Suhrkamp, è anche un segno del peso che sempre più le case editrici coinvolte nel progetto assumono nei confronti degli scrittori. Boehlich rimprovera Blanchot d’essere “astratto” e di neutralizzare nel simbolico un evento concreto come il muro di Berlino. Ma quell’evento doloroso non era un problema solo nazionale; era il problema della divisione. Quanto all’astrattezza, il muro “ha inteso astrattamente concretizzare la divisione, renderla visibile e tangibile”, diceva Blanchot. E indicava la sua importanza e il suo scandalo “nel ricordarci ciò che di continuo dimentichiamo: che l’astrazione [...] è il nostro mondo, quello in cui giorno per giorno viviamo e pensiamo” . Il problema di Berlino, pur nella sua specificità, riguardava tutti: era un segno della frattura dell’Europa . E fu anche una delle cause principali del fallimento di «Gulliver», per quanto i francesi continuassero a ripetere che la reciproca diversità culturale e politica era la base su cui costruire una rivista internazionale nuova.
Cos’era in gioco in esse? Uno spirito comune “magari in analogia ai tentativi di integrazione economica, alla formazione di assi politiche e di blocchi militari”? Così meditava la Bachmann tra sé e sé: “come se dovessimo fondare anche un supermarket dello spirito, solo perché è appena nato il Mercato comune, il supermarket Europa, e il burro europeo, le biciclette europee e i giocattoli di tutta l’Europa sono ormai a portata di mano...” .
Ma l’idea d’Europa degli scrittori coinvolti nell’ipotetica rivista internazionale non ha molto a vedere con discorsi di tipo economico, tecnico o pratico. Il progetto, come si è detto nella “Cronaca”, comincia a delinearsi in seguito a un evento politico: la guerra d’Algeria. Una guerra attorno alla quale ruotano due iniziative: «Le 14 Julliet», una rivista d’opposizione a De Gaulle che nel maggio del ‘58 si impadronì del potere e la Déclaration sur le droit à l’insoumission, stesa nel ‘60 e nota come il Manifesto dei 121 . Qui la politica si sposa col sogno comunitario e consente di esperire un modo d’essere insieme singolare. Agli occhi di Maurice Blanchot la sua singolarità risiede nella “forza impersonale” di un appello condiviso da tutti i firmatari. I quali hanno dato il loro nome, ma l’hanno spogliato dell’identità; l’hanno liberato dal peso sociale dell’io: “La dichiarazione ha rappresentato per loro una certa comunità anonima di nomi” . E quell’ossimoro - quell’anonimia di nomi - fa supporre che è stata messa in gioco l’autorità delle singole persone e addirittura il privilegio del soggetto . Anche la rivista internazionale che si sarebbe di lì a poco progettata, avrebbe chiesto ai suoi membri la rinuncia a ogni condizione di privilegio:
Costa una fatica ben più grande parlare ad amici e collaboratori distanziati, a un pubblico distanziato, lavorare in comune, quando occorre ancora uno sforzo per vedere la comunanza [...] - costa la rinuncia alla posizione dei singoli scrittori, che si presume solida ma che altrove potrebbe non apparire persuasiva, la rinuncia alle allusioni condizionate dall’idioma, la rinuncia al grado dei singoli scrittori, ai diritti derivanti dal grado.
La prima nozione cui ci troviamo di fronte in una lettera a Sartre di Blanchot, che di «Gulliver» fu il più appassionato promotore, è quella di comunità. Per i francesi la tradizione comunitaria affondava le radici molto indietro nel tempo: risaliva all’esperienza surrealista, quindi, a George Bataille e al misterioso controgruppo di Acéphale, la cui illusione era l’abbandono (“abbandono di e all’angoscia ultima che dà l’estasi”) vissuto in comune. Affascinato dalla sociologia che gli diede una conoscenza e insieme un senso nostalgico dei modi d’essere comunitari, Bataille si spinse lontano nell’esperienza della comunità, alla cui base intravvide un principio d’incompletezza. Blanchot, tornando a riflettere sull’argomento, si chiede: “perché comunità?” E come lui risponde: “Alla base di ogni essere esiste un principio di insufficienza”, la quale, a sua volta, fa appello alla contestazione che è sempre “esposizione a un altro (o all’altro)” .
I tedeschi avevano alle spalle l’appartenenza al Gruppo 47, che nel secondo dopoguerra riunì, in nome di un impegno etico, molti scrittori di lingua tedesca (tranne coloro che vivevano nella RDT): Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger.
In Vittorini, invece, la comunità si era connotata di valenze politico-allegoriche nel sogno del villaggio delle Donne di Messina del ‘49. Poi, negli anni cinquanta, il concetto si era caricato di senso operativo esprimendosi nel movimento di “Comunità” e della sua rivista e nel modo d’essere comunitario dell’azienda Olivetti, da cui restò fino agli ultimi anni affascinato.
Ma sono i francesi a elaborare un’idea teorica di comunità secondo il principio che “l’esistenza di ogni essere fa appello all’altro o a una pluralità d’altri” . Un comunità come forma dinamica: che fa leva sull’incompletezza e fa del processo la propria caratteristica strutturale. Una comunità “in vista della comunità”, per dirla con Blanchot: che prende forma nel suo stesso farsi e si offre come tensione sino a ipotizzare un movimento infinito. Tanto che Leonetti scherza sul pericolo di proiettare nel cielo dell’ideale sia la comunità sia la rivista: “Il bello è che è già una non-revue così com’è: invece di fare, si progetta e ci si convince a progettare [...]. I francesi sono da sforzare: in quanto per essi la vera rivista è ‘il movimento verso la rivista’” .
Nella Declaration la comunità era nata spontaneamente, da un evento. Così si sarebbe sviluppata nella rivista. Il filosofo polacco Kolakowski la definisce “genetica” e dice che rinvia a “un fatto, non a un programma”; che l’intesa è costituita da un atteggiamento intellettuale “nato da esperienze e crisi simili, benché vissute separatamente”; non dall’adesione a “una piattaforma ideologica” .
Ma l’aggettivo “genetica” rinvia anche a un sodalizio che si fonda su un dato spontaneo e naturale: non è forse il linguaggio e, nel nostro caso, la scrittura? Difatti, il fine di questa comunanza che si mantiene aperta alla ricerca e non fonda progetti o manifesti politici è di esprimersi in “una rivista di pensiero fatta da scrittori”. Senza dar peso al loro nome: ovvero, oltre la limitatezza del principio d’identità che li distingue. Sarà la scrittura, così pensano tutti i collaboratori, a garantire quell’anonimia di cui parla Blanchot, perché sfugge a qualsiasi forma di identificazione: “Cosa importa chi parla? - si domanderà qualche anno più tardi Foucault . Scrivere è perseguire soltanto il destino del linguaggio: giocare il nome, arrischiare la soggettività dell’autore, disfarsi dell’io per accedere all’anonimato di un’esperienza che non vuoi essere battezzata da alcuna attribuzione o proprietà”. Affermano i francesi che la scrittura sospende l’adesione in prima persona con il proprio discorso e spiazza qualsiasi ruolo: “Scrivere è entrare nell’affermazione della solitudine, dove incombe la fascinazione. È consegnarsi al rischio dell’assenza di tempo, dove regna l’eterno ricominciamento. È passare dall’Io all’Egli, di modo che ciò che mi avviene non avviene a nessuno, è anonimo” .
È a partire da questo spiazzamento e da questa cancellazione che si tenterà di mettere in scacco non solo l’identità individuale (l’autore) e collettiva (il gruppo), ma tutti i concetti su cui si fonda la storia dell’occidente: “l’idea di Dio, dell’Io, del Soggetto, quella della Verità e dell’Uno, quella del Libro e dell’Opera” ; che si tenterà di spezzare il sapere della totalità nel suo complesso. Quel sapere che aveva costruito le sue certezze sulla logica della continuità, la cultura dell’identico, il linguaggio delle risposte.
Nei primi anni sessanta l’Europa sta vivendo un trapasso epocale e, nell’inquietudine diffusa, si presentisce il cambiamento. Non essendo più rassicurati da alcuna risposta, si può solo dubitare delle certezze consolidate; offrire ipotesi anziché conclusioni; reagire interrogandosi e tentando di formulare nuovi concetti: “È il lavoro comune, lo sforzo di riflessione comune, di cui la rivista sarà il mezzo e l’affermazione concreta, che potrà, in una ricerca aperta e collettiva, offrire forse non delle conclusioni, ma un metodo critico nuovo, una nuova discussione”.
Se è vero che da solo “l’essere si chiude, si addormenta e si tranquillizza”, è altrettanto vero che l’intesa tra i collaboratori, non poggiando su un sistema di valori prestabilito, è sentita come una possibilità e la rivista “resta una scommessa su questa possibilità”. Perché, costituirsi in un collettivo vuoi dire mettere in moto un processo di comunanza; non darlo per scontato: “ciascuno, mettendo in comune i suoi sforzi, le sue domande, le sue risorse, attraverso il superamento interiore delle sue posizioni di pensiero, è condotto - per il fatto stesso che la rivista esiste - un po’ al di là o un po’ al di fuori del cammino che da solo avrebbe percorso, e diventa responsabile di asserzioni di cui non è l’unico autore o di una ricerca che non è soltanto sua”.
La strada verso una siffatta comunità non passa né per un collettivo di intellettuali che condividono una stessa fede, né per un’associazione cosmopolita di nazioni arroccate alla loro specificità (nel qual caso permarrebbero i particolarismi e il pensiero resterebbe confinato nei limiti del provincialismo nazionale). La comunità che informa il progetto «Gulliver» vuoi essere una comunità internazionale “in senso essenziale”. E ciò significa che
lo stesso sforzo di superamento richiesto individualmente da ciascuno deve essere compiuto, in proporzione, da ogni gruppo nazionale. Mettendo in comune i problemi letterari, filosofici, politici, sociali, così come si pongono nel contesto di ciascun paese e di ciascuna lingua, ognuno rinuncia a un diritto esclusivo di valutazione dei propri problemi e riconosce che questi appartengono anche agli altri. Non si tratta di privare della loro specificità i problemi propri di quella regione del mondo ma, al contrario, di coglierne la specificità in quanto tocca la questione generale
Significa cioè che l’idea stessa di comunità internazionale esige di guardare con uno stesso colpo d’occhio sia all’identità che alle differenze; sia ai problemi specifici che generali. O meglio, esige di pensare alle diversità nell’unità europea.
Siamo a una svolta che non consente più di ripercorrere le vecchie strade: “qualcosa di decisivo accade e cerca di affermarsi” e quest’inizio non può iscriversi nel solito scenario di riviste “senza necessità”.
A Sartre che guarda ancora a «Les Temps Modernes», Blanchot scrive: “Io credo che se vogliamo rappresentare come si deve, senza equivoci, il cambiamento che abbiamo reciprocamente presentito, se vogliamo renderlo più concreto e approfondirlo, nella sua inafferrabile presenza, nella sua nuova verità, potremo farlo solamente a partire da un organo nuovo” .
Che non può essere una rivista di cultura: congelata ormai in un “genere”, enciclopedica, e perdipiù con un’identità ideologica. Né un collettivo fondato sulle affinità - letterarie, politiche o culturali - delle nazioni coinvolte. Una rivista che si fondasse su elementi affini:
non avrebbe mai potuto avere una struttura sua propria, nuova per tutti, e unitaria:unitariamente nuova [...].Ogni gruppo vi avrebbe conservato, grazie alla mancanza di attrito data dalla certezza tranquillizzante dell’affinità, la sua vecchia struttura di gruppo nazionale, col suo particolare colore nazionale; e non si sarebbe avuta, alla fine, che una sovrapposizione di tre volte la stessa struttura, ma in tre diverse accezioni, tre diversi colori che mai avrebbero potuto fondersi in un unico colore nuovo.
In questo modo non ci sarebbero stati né comunanza né dialogo e sarebbe sortita una rivista “di pura e semplice omologazione. Ovvia”. L’unità verrà fuori “attraverso l’ingranarsi non di risapute affinità più o meno sovrapponibili, e in ultimo sterili, ma di difformità reciprocamente provocatorie”, scrive Vittorini’ . E i francesi aggiungono che la comunicazione si sarebbe instaurata a partire non da un’intesa ma da una dissimmetria.
È subito chiaro che si va facendo strada un nuovo concetto. Le parole perdono il senso che la lingua abituale ha loro conferito e mettono in gioco un’idea di dialogo estranea alla pacifica composizione. Il dialogo è pensato come una via che passa per la differenza. Difatti, se il pensiero è domanda, non può non essere confronto di alterità e con l’alterità: abbandono di un unico senso, di un unico orizzonte, di una risposta unica e definitiva e ricerca invece di una parola plurale, che unisce nella separazione. Si chiederà più tardi Blanchot: “Come può affermarsi la ricerca di una parola plurale fondata non più sull’uguaglianza, non più sul predominio e la subordinazione, non sulla mutualità reciproca, ma sulla dissimmetria e l’irreversibilità, in modo che tra due parole esista sempre un implicito rapporto d’infinità che sia come il movimento del significato stesso?”.
Sono i francesi che, riflettendo sul concetto di differenza, approdano a una nozione non dialettica di dialogo. Mascolo medita in termini paradossali sui folli di un ospedale psichiatrico, in contatto diretto fra loro e tuttavia ignoti gli uni agli altri, “alterità pura”:
Comunicazione da ferita a ferita, da dolore incomunicabile a dolore incomunicabile, da solitudine a solitudine: un segreto proferito collettivamente. Niente di simile a un dialogo. Nessun impiego della parola che tenda a restringere l’abisso della differenza. Il senso di una simile società sta nella presenza di un principio nuovo, che non appartiene propriamente a un ordine poetico, né propriamente a quello della carità, ma forse consiste in una carità poetica. E la figura pregnante di un comunismo meta-fisico. Permanendo fino in fondo la separazione, le differenze inessenziali sono sop-presse. E così si spiega che il dialogo come confronto “pacifico”, correttivo idealistico alla guerra dei prestigi, alla competizione mercantile, e alle loro conseguenze - il dialogo caro agli umanisti - sia diventato inutile
Lo stesso concetto è espresso da Blanchot nell’Infinito intrattenimento: il dialogo nasce dalla separazione, non da un accordo. E anche Barthes smaschera l’utopia liberale che lo vuole come “luogo d’incontro di due buone volontà” .
Dunque, se il dialogo fa leva sulla differenza, una rivista che non voglia essere “di pura e semplice omologazione” è tutta da inventare. Uno dei compiti, ripete Mascolo, “è l’elaborazione della rivista come forma da scoprire e la messa in opera di tale forma” . E prefigura con le sue parole anche un concetto di comunità del tutto nuovo: in cui la scrittura stessa che ne sta alla base è uno “spazio d’interrogazione”.
Non per caso, il senso e la necessità del domandare sono all’origine della differenza fra una rivista di cultura e una rivista letteraria:
Oggi, al punto in cui siamo, dopo Marx e dopo Lenin, la cosa difficile non è rispondere, è interrogare, è parlare interrogando. Ecco perché possiamo apparire meno uomini di cultura dei nostri partners: perché siamo consapevoli, quasi in modo esagerato, dello scarto che esiste tra l’affermazione culturale e l’affermazione artistica o letteraria; consapevoli anche che questo scarto rappresenta ciò che precisamente sfugge a ogni processo di unificazione.
È così che scrittori di più paesi, diversi per tradizione, lingua e cultura si uniscono insieme per una comune abitudine intellettuale a interrogarsi, a mettersi in questione. E il loro legame, anziché sopprimere, esalterà le differenze perché si fonda sulla scrittura, che è il segno più emblematico della solitudine e dell’alterità.
La verità della scrittura
Può capitare che una testimonianza esistenziale o politica prenda forma di letteratura; che un’opera finisca per rivelare una “verità sotterranea” e iscriversi nella memoria degli uomini: nella storia. In tal caso svolge, attraverso il lavoro solitario dello scrittore, un compito di “politica indiretta”. Perché c’è sempre uno iato fra la realtà e la presa letteraria su di essa. Come nel romanzo di Uwe Johnson su Berlino: “Forse il lettore e il critico frettolosi potranno dire che, in opere di questo tipo, il rapporto col mondo e con la responsabilità di una decisione politica nei confronti di esso resta lontano e indiretto. Indiretto, sì. Ma c’è appunto da chiedersi se, per aderire al mondo con la parola e soprattutto con la scrittura, una via indiretta non sia la via giusta, e anche la più breve” .
Quando lo scrittore parla “in quanto scrittore e nella prospettiva che gli è propria”, si assume la responsabilità che “gli deriva dalla sua verità di scrittore”. Una verità che corrisponde alla sua “più intima ragion d’essere” e si sottrae al rischio autoritario perché ha origine dal dubbio. Una responsabilità del tutto diversa da quella che, a partire dal ‘45, ha “brutalmente” marcato i rapporti fra letteratura e vita. Il tempo dell’engagement sartriano si è concluso: al vecchio impegno, ch’era “di parte” o di partito, si sostituisce un dovere etico “impersonale”; a un mandato che investe l’individuo e risponde della parola in prima persona, si sostituisce la responsabilità dello scrivere, che va al di là del soggetto. Una responsabilità anonima, oltre il singolo autore o il singolo paese: “La rivista deve rappresentare nella vita intellettuale, politica e letteraria una certa forma di responsabilità e, attraverso essa, affermare un’autorità intellettuale che non è né l’autorità di una persona né di un gruppo, ma corrisponde all’esigenza impersonale della ricerca letteraria e filosofica. E non è data in partenza, ma si svolge col movimento di pensiero che la rivista produce” .
Un concetto difficile, quello dell’autorità intellettuale da conquistare col tempo: s’impernia sulla struttura della rivista come movimento d’insieme e i francesi vi insistono fino all’ultimo anche se, forse, è stato concepito un po’ astrattamente e ha finito per provocare una “rottura rovinosa”. Ma nelle intenzioni di Blanchot era chiaro: “se la direzione internazionale non può essere esercitata in modo autoritario direttamente sul contenuto dei testi (e sarebbe possibile solo se la rivista pretendesse d’incarnare un’ideologia), essa tuttavia può e deve esercitarsi sulla struttura, la forma, la coerenza e il movimento d’insieme di ogni numero. Struttura che custodirà il senso ultimo della nostra impresa e le sue possibilità di futuro” .
Si è parlato di scrittura come luogo di responsabilità (solo più tardi Barthes introdurrà il postulato del luogo di godimento e di piacere). Si tratta di una responsabilità nuova, epocale: della scrittura di fronte al pensiero. Al pensiero e non alla filosofia. Scrivere comporta “una tremenda responsabilità”: presuppone “un radicale cambiamento d’epoca - la morte stessa, l’interruzione - o, per usare un’espressione iperbolica, la fine della storia . E poiché la storia che l’occidente ha conosciuto è improntata all’idea di continuità e di progresso, l’iperbole suona come liberazione dalla dialettica e da tutte le rappresentazioni di cui l’uomo è ancora prigioniero. Di qui l’insistenza dei francesi sulla discontinuità e sul frammento che la raffigura: “oggi la discontinuità è l’essenza stessa del mondo. Quasi che si trattasse per noi di edificare un mondo - l’universo, l’affermazione più totale, più unificata - proprio sul carattere disarticolato, disarmonico, frantumato dell’essere, o sulle carenze dell’uomo” .
La letteratura
La rivista si qualifica soprattutto per il suo carattere letterario, ma qual è l’idea di letteratura che coltiva? Finora la letteratura era stata pensata soprattutto come veicolo di contenuti; al di fuori del linguaggio. E l’opera letteraria si era messa in rapporto con la società, la storia o l’estetica. I primi a postularla come un linguaggio sono stati i francesi e proprio in un momento in cui l’ideologia ancora trionfante era quella della rappresentazione. Quel che oggi sembra naturale, confessa Roland Barthes, “ha dovuto essere conquistato”. Allora, definire la letteratura un linguaggio parve una provocazione di carattere formale: sembrò quasi si volesse negare il suo potere “realista (protetto dall’alibi sociale e, in certi casi, socialista)” . In realtà, in questa sua nuova veste era un terreno vergine. Diceva, sempre Barthes agli inizi del ‘60: “Stiamo uscendo da un momento, quello della letteratura impegnata. La fine del romanzo sartriano, l’imperturbabile indigenza del romanzo socialista, la carenza del teatro politico, tutto questo, come un’onda che rifluisca, lascia scoperto un oggetto singolare e singolarmente resistente: la letteratura” . E pensava alla letteratura come esperienza del linguaggio e ricerca interminabile del senso. Ma il linguaggio è ambiguo, contraddittorio e la sua doppiezza è strettamente legata al rapporto con l’altro. Per i francesi, e in particolare per Blanchot, è proprio la scrittura a farci sentire, nel linguaggio, una relazione di alterità radicale, assoluta. E non è un caso che in «Gulliver» la letteratura diventi sinonimo di écriture e le si accordi una duplice valenza: interrogativa e di ricerca. Perché il senso della vita, forse consiste in un interrogarsi privo di risposta o, in altri termini, la dimensione più propria del linguaggio è quella di “porre domande reali, domande totali” . Domande che rifiutano il principio stesso del dominio, dato che il linguaggio, si sa, è per eccellenza potere e ci getta nella dialettica del servo e del padrone:
Bisogna tentare di riafferrare nell’opera letteraria il luogo dove il linguaggio è ancora relazione senza potere, linguaggio del rapporto nudo, estraneo a ogni padroneggiare e a ogni servire, linguaggio inoltre che solo parla a chi non parla per avere e per potere, per sapere e per possedere, per diventare padrone e padroneggiarsi, cioè a un uomo assai poco uomo. E certamente una ricerca difficile, benché noi siamo, con la poesia e l’esperienza poetica, sulla linea di questa ricerca
.
Se la letteratura era pensata come altro da sé, come strumento immediata-mente politico, ora è pensata come un’esperienza critica globale che sottopone a revisione tutti i campi della vita. Si dice: perché la parola “critica” ritrovi il suo senso, è necessario si estenda a ogni aspetto dell’esistenza. Sarà l’intera realtà a essere criticata, e questa critica, ripete Enzensberger, “sarà fatta da scrittori”. Non basta la critica della cultura, che “pretende di mettere in questione in modo idealista l’esistente, come se non ne facesse parte . Così Mascolo: “La letteratura costituisce un’esperienza radicale, fondamentale, perché mette in questione tutto, compreso se stessa. Non essendo unicamente affermazione delle opere, ma ricerca di sé, contestandosi essa stessa e conte-stando al contempo tutte le altre forme di potere, non deve essere sottomessa ad alcuna restrizione, ad alcuna sorveglianza dogmatica” .
Contesterà il potere, la dialettica con la sua idea di progresso, se stessa. E rifiuterà ogni barriera: lo specialismo, le frontiere della civiltà (“non esistono regioni particolari”, avverte la Bachmann), la separazione tra le discipline e fra scritti critici e creativi. Più volte in «Gulliver» si ripete che non deve esserci divisione fra l’antologia dei testi e la parte saggistica; che critica e invenzione si metamorfosano l’una nell’altra; che qualsiasi problema verrà affrontato dallo scrittore e non dagli specialisti. D’altro canto, se torniamo all’espressione “rivi-sta di pensiero fatta da scrittori”, ci accorgiamo che la scrittura, lungi dal separare invenzione e teoria, è intesa come un atto di pensiero risolto in linguaggio. Che, rispetto ai vari linguaggi, dal politico al matematico, ha “il vantaggio d’essere l’unico globale. Tutti gli altri linguaggi culturali sono separatisti. Solo quello letterario è unitario”, dice Vittorini. E aggiunge che avrà il vantaggio sulla lingua parlata “(per natura convenzionale e approssimativa) di tendere alla precisione (come dimostrano le sue stesse possibilità figurative)” . Ma si tratta di un’unità che vive delle differenze e che fa della domanda la sua stessa essenza. Perché, a sentire Blanchot, viviamo un grande cambiamento: siamo passati dall’epoca della filosofia come sapere della totalità a quella della letteratura come pensiero della differenza. Ed è proprio la scrittura il luogo dove prende forma un pensiero che pensa ciò che è oltre la totalità, oltre la filosofia. L’inaugura l’epoca in cui tutti i concetti della cultura dell’occidente s’inverano e, insieme, rischiano di tramontare. Con le sue stesse parole: “Noi apparteniamo alla fine della filosofia, fine necessariamente ambigua [...] che, in quanto fine, non finisce affatto, può durare lunghe epoche storiche, ma che, come tale, ci investe di compiti radicalmente altri, ai quali non corrispondono più le vecchie etichette”. Quel tempo vien chiamato “comunismo”, ma è solo un nome. Con l’abolizione della vecchia società divisa e con l’avvento di un mondo politicamente, socialmente e culturalmente unificato, sembra raggiunto il fine della metafisica occidentale (e della tradizione dialettica): ricondurre tutto sotto il dominio del concetto. Ma la realizzazione pratica di questo fine rischia di coincidere con la fine della filosofia. Solo il linguaggio può raccogliere la sfida, interrogandosi e guardando all’unità come al limite al di là del quale si estende il territorio sconosciuto di un pensiero che pensa il mondo non più nella sua totalità, ma nella sua differenza:
In quanto scrittori siamo già nel comunismo, ed essendoci, la risposta è data: è la risposta dell’unità comunista. Ma, a partire di qui, a partire dal momento in cui ciò che si richiede alla parola è d’essere qualcosa d’altro che una risposta, da questo momento comincia ad affermarsi l’esigenza propria di ogni linguaggio letterario: quella d’essere essenzialmente domanda, l’interrogazione radicale che non è detto l’uomo possa sostenere, allo stesso modo in cui non è detto ch’egli sia capace di letteratura.
La parola frammentaria
I concetti teorici che informano il progetto di rivista e di comunità internazionale vengono elaborati soprattutto dai francesi. E sarà sempre il loro gruppo così “omogeneo” rispetto al tedesco e all’italiano, a proporre una rubrica attorno alla quale la revue dovrebbe ruotare e organizzarsi. Il suo nome, Cours des choses, accenna al farsi delle cose, a una realtà in divenire, cui corrisponde l’idea stessa di una comunità in movimento. Ma è proprio su questa rubrica che rivista e comunità si romperanno. Soprattutto perché si affida alla “parola frammentaria”: una scrittura di brani fra loro fortemente discontinui, ancora insolita al pensiero europeo.
È vero che il Cours si presenta come un luogo di sperimentazione e di ricerca, tuttavia la scrittura per frammenti sconcerta le abitudini tedesche e italiane legate ancora al genere saggistico. Per i francesi la “forme courte” non risponde a un semplice mutamento di valori retorici, ma è l’espressione dello scacco del linguaggio: dice la perdita della totalità, la separazione, l’assenza di un fondamento. Ed è elevata a principio non tanto estetico quanto ontologico: “Ciascuno, dal momento che non è più saldato al tutto (dal momento che questa illusione di essere saldato al tutto gli è stata tolta), sembra essere ridotto a niente più che un frammento, fra tanti, di un insieme scomparso” .
A differenza del saggio che è una forma espressiva in sé conclusa, la scrittura per frammenti lascia intuire che non tutto è detto; che il linguaggio non è più soggetto a una forma unitaria ed esaustiva; che ha perduto ogni riferimento e ogni illusione di totalità. Così i francesi ripeteranno agli altri gruppi nel loro Memorandum: “Ciascun testo non solo sarà breve [...], ma costituirà come un frammento, che non esaurisce necessariamente tutto il suo senso in se stesso, ma si apre su un senso più generale ancora a venire” .
Col titolo dell’ultima raccolta poetica di René Char, Blanchot chiamerà “parola in arcipelago” questa nuova figura della dispersione del linguaggio che sfugge alle insidie del continuum e libera il pensiero dall’essere pensiero solamente in vista dell’unità; che non tollera alcun riferimento né a un centro né a un’origine, senza alcuna garanzia, si espone al rischio dell’impensabile e del silenzio. Non è uno stile fra gli altri, ma una forma sostanziale. Anzi, per i francesi è la sola forma della scrittura , perché l’unica che possa render conto di uni domanda ininterrotta.
La scelta deliberata del frammento “non è ripiegamento scettico, stanca rinuncia t una sintesi completa (potrebbe esserlo): ma un metodo paziente-impaziente, mobile-immobile di ricerca, e l’affermazione - inoltre - che il servo, l’integrità del senso non può trovarsi immediatamente in noi e in ciò che noi scriviamo, ma che è ancora a venire e che, interrogando il senso, noi lo costiamo come puro divenire e avvenire interrogativo» .
l testi frammentari non vanno letti isolatamente perché il loro significato dipende dal rapporto che istituiscono con tutti gli altri scritti. I quali sono legati fa loro dal bisogno di leggere il mondo attraverso una pluralità di voci e di riflessioni. Ma occorre armonizzarli in una struttura generale, impedendo che “la rivista rischi di disperdersi nell’informe, come accadrebbe se la diversità di questi testi molteplici non si componesse e non si articolasse in un progetto d’insieme” .
Blanchot fa eco Barthes che ipotizza “una dispersione concertata di frammenti, di figure, di parole” . D’altro canto, non si dimentichi, l’avventura detto strutturalismo iniziava in quegli anni il suo cammino. Barthes considerava il frammento “una unità strutturale” che esiste soltanto “in rapporto ad alte unità” e aggiungeva: “il frammento non ha senso in sé, ma è tale tuttavia che la minima variazione apportata alla sua configurazione provoca un cambiamento dell’insieme” .
La “forme courte” - nel senso “che si dà a questo termine nella musica d’oggi” - annuncia un’esperienza non dialettica: fa parlare la discontinuità e l’intermittenza; smaglia il discorso coerente e sistematico; spezza la logica che confida nella verità da dimostrare e illuminare “a giorno” ; esprime il pensiero della domanda. Solo la domanda, infatti, rompe la violenza dell’unità e del sistema in cui si esercita il potere del logos.
Anche il problema della divisione di Berlino è formulato da Blanchot frammentariamente: perché è impossibile abbracciare in un unico sguardo la sua realtà completa o parlarne in termini che si presumano esaustivi. Il suo senso può essere solo interrogato ed espresso per approssimazioni, per aggiunte, per continue domande: “Fino al 13 agosto 1961, l’assenza di un segno di separazione visibile - anche se una serie di controlli regolari e irregolari faceva sentire l’approssimarsi enigmatico di una linea di demarcazione - dava alla spartizione un carattere e un significato ambigui: che cosa era? Un confine? Certamente: però anche qualcosa d’altro; meno di un confine, visto che ogni giorno lo si poteva varcare in massa sfuggendo al controllo, ma anche assai di più, poiché varcarlo era passare non già da un paese a un altro, da una lingua a un’altra, ma, entro il medesimo paese e la medesima lingua, dalla “verità” all’‘errore’, dal ‘male’ al ‘bene’, dalla ‘vita’ alla ‘morte’” .
Come la comunità, anche il frammento nasce da una incompletezza. Se il saggio circoscrive l’oggetto di cui parla e conclude, il frammento annuncia una relazione d’apertura: senza illudersi d’esaurire il discorso, provoca, interroga, si prolunga nella riflessione che segue e trova il suo senso nel rapporto con tutti gli altri frammenti che si presuppongono e si rinviano reciprocamente.
È così che il Cours - composto di testi frammentari - diventa metafora del legame che si tesse fra uno scritto e l’altro, e quindi, del colloquio fra i diversi interlocutori. Metafora di un’unione e di una comunità, che non è data a priori né si compie una volta per tutte, ma diviene e si fa nel movimento interrogativo e dialogico. Metafora, infine, di una rivista che è alla ricerca della propria forma e del proprio “tono”, per dirla con la Bachmann, e li troverà se saprà articolare e comporre la pluralità dei diversi pensieri, dei diversi frammenti in un’architettura, senza che “l’insieme significativo” cui ogni numero darà vita, s’imperni su un tema o sul contenuto del discorso.
I numeri “formeranno un tutto senza essere dei numeri monotematici’ - si ripete nei Testi preliminari. O ancora: “Il mondo non è tematizzabile”. Ed è per questo che i francesi rifiuteranno il tentativo vittoriniano di compilare delle schede con argomenti sui quali interpellare gli scrittori e insisteranno sul fatto che il senso del Cours, cardine della rivista, “deve svelarsi e manifestarsi” attraverso la sua forma.
Le schede, se da un lato soddisfano l’esigenza di non casualità e acconsentono a una struttura, a una forma , dall’altro, sono soltanto espedienti che forzano l’interesse dell’autore senza minimamente provocarlo. Perché è la differenza di più punti di vista che provoca e spinge al confronto.
La differenza
La rivista, si è ripetuto più volte, si sarebbe fondata sul confronto e la loro vocazione fra “tendenze letterarie molto diverse l’una dall’altra”, perché solo così avrebbe potuto dar vita a un nuovo legame. Ovvero, a una comunanza e a un’unità nuova: che accetta la disgiunzione e la divergenza e, anzi, fa leve su esse. Purtroppo però l’internazionalità rimase un’utopia e le differenze, sia letterarie sia politiche, generarono un costante malessere fra i gruppi. Nel uso dei tedeschi, al marchio nazista si aggiunge, nel presente, la divisione di Berlino che arriva a compromettere persino l’identità nazionale. Il rapporto che la Germania coltiva col passato costituisce un peso insopportabile da rimuovere: “I ragazzi del gruppo tedesco sembrano considerare che la politica culminata nel nazismo ha privato di ogni validità di tradizione positiva gotto quello che è stato detto in Germania da Goethe in poi; sicché anche le parole che noi o i francesi o non so chi altri possiamo ancora tenere per fondamentali da Hegel sono per loro infide, pericolose” .
E un peso che mina l’internazionalità della rivista perché porta a voler ricostruire un’identità nazionale di cui non vergognarsi e a privilegiarla. La Germania, su cui sembra gravi un senso di colpa storico-epocale - come un complesso di persecuzione “etnica” - vive una condizione di vero e proprio sgretolamento: etico, linguistico, politico. Il nazismo e la costruzione del miro che divide Berlino sono sentiti come una ferita che attraversa il popolo.
Ripetono i francesi: “Non si tratta di privare della loro specificità i problemi propri di una regione del mondo ma, al contrario, di coglierne la specificità in quanto tocca la questione generale” . Tuttavia il muro di Berlino isola i tedeschi in una loro specifica differenza e rimette continuamente in gioco la loro partecipazione al progetto: “Berlino puzza di guerra e di paura [...]. Per me non è un fatto di cronaca ma un evento capitale”, grida Enzensberger . E allora? come lavorare serenamente a una comunità europea? Mentre Mascolo, ostinato, ripete che la responsabilità sarà internazionale (“non ci sono né direttori né comitati di direzione nazionali”), i tedeschi avvertono l’urgenza di un organo di stampa, ma preferiscono un mensile tedesco a una rivista a direzione collettiva. D’altra parte, essendo ormai divisi in due entità incomunicabili fra loro, cosa può significare “pensare in europeo” se non si sa neppure cosa significhi “pensare in tedesco”? La Bachmann vuol scoprire la propria identità nazionale, prima di pensare a una comunità internazionale. Non abbiamo “voglia di allearci nel modo corrente”, dice, perché “ci manca ancora tanta comprensione di noi stessi, una comprensione nuova, asentimentale, che non è ancora del tutto possibile” . Il concetto che la guida è che comunicare con l’altro è un’occasione per conoscere meglio se stessi e i problemi della propria nazione. Formare un “triangolo” francese, italiano, tedesco, è auspicabile sol-tanto se serve a parlare “in maniera un po’ diversa per diventare più esatti nella rappresentazione di se stessi, e per rappresentarsi con una maggiore esattezza gli oggetti nella loro scala d’importanza”; se possiamo esercitarci a parlare delle nostre cose, “mentre di solito è difficile farlo nel proprio paese”: “Infatti, quando parliamo nella nostra lingua ai nostri connazionali, siamo tutti tentati di fare assegnamento sull’ovvietà familiare, di trattenerci nell’intimità storicopolitico-culturale (perfino con i nostri avversari), ad appoggiarci comodamente a presupposti che non è più necessario verificare” .
Questa giusta spinta a comunicare e ad intendersi tra nazioni diverse può essere strumentalizzata però dalla vacua propaganda europeista della riconciliazione, dietro la quale si nascondono concreti interessi economici d’unificazione e d’espansione dei mercati: se prima si strumentalizzava il conflitto, oggi si strumentalizza l’ingenuo desiderio dei popoli di abbandonarsi “dopo tanto odio manovrato, a un amore altrettanto manovrato”. Dunque è necessario appellarsi alla ragione: per comunicare autenticamente con l’altro non servo-no gli ipocriti appelli solidaristici, ma una piena consapevolezza della propria identità: “Pensare in europeo? Chi non si sentirebbe imbarazzato, dal momento che, per esempio, non sappiamo neppure che significa pensare in tedesco o in austriaco, e non vorremmo neppure saperlo o farcelo dire, perché non ce ne ripromettiamo niente di buono” .
Non potrebbero esserci parole più attuali, oggi che alla retorica europeista si è aggiunta l’altrettanto vacua retorica della multicultura e dell’integrazione con il diverso, il cui concetto si rivela tanto vuoto quanto è stato radicale l’annientamento che abbiamo compiuto delle culture altre nei loro luoghi di origine, privandole di ogni memoria e identità, sì che non resta loro che l’ossessivo desiderio di assimilarsi e di identificarsi con i modelli più convulsi del nostro modo di vivere.
Tutti gli articoli dell’équipe tedesca apparsi sul «Menabò» n. 7 testimoniano l’urgenza di ridefinire l’identità nazionale. La Germania, dice Uwe Johnson, non è più una nazione: né in senso geografico (perché non ha una capitale), né in senso storico (perché non ha un passato cui riferirsi). E diventata una provincia ed entrambe le zone in cui è stata divisa sono asservite all’interesse di parte. Ma, “così come i resti del territorio statale tedesco, divisi sono anche i modi di vita” e gli scrittori dei due paesi:
Già prima della totale abolizione della libertà di spostamento, nel migliore dei casi, agli emigranti era possibile mantenere nella memoria e nel sentimento sia la situazione abbandonata sia quella scelta, e quando, per le premure dedicate all’una, la coscienza dell’altra non si spezzava immediatamente, di lì a poco tempo essi erano ignorati quanto gli scrittori locali, per i quali l’altra terra era sempre stata, fin dall’inizio, più lontana che non la Polonia o l’Algeria, e ciò, appunto, non soltanto per ragioni di pericolo politico.
Neppure sul piano linguistico la Germania riesce a essere una nazione. Sebbene la lingua sia l’elemento comune, paradossalmente gli scrittori occidentali e orientali non riescono a parlarsi. L’estraneità degli uni agli altri impedisce qualsiasi intesa e anzi li distanzia e li induce in errore: “deforma perfino il comportamento reciproco degli scrittori dei due paesi, quando per esempio in occasione della costruzione di un muro di sbarramento attraverso Berlino e della posa di mine lungo la linea di demarcazione attraverso il territorio tedesco scrittori occidentali invitano i loro colleghi orientali a unirsi alla protesta contro le misure del governo comunista, e agiscono per così dire in modo intertedesco” .
Parole e concetti come, ad esempio, “progresso, sinistra borghese” o “reazione” suonano in modo diverso nei due paesi; ingenerano equivoci che avviliscono la lingua; creano addirittura “avversari per malinteso”:
Gli scrittori di entrambi i paesi si sono lasciati allineare, identificandosi, o lasciando-si identificare con gli interessi politici del governo del paese in cui abitavano, o perlomeno rendendo gli interessi dell’altro governo definizione negativa del proprio atteggiamento. Questi antagonisti, che stanno dalle due parti e che insultano, denunciano, svergognano, ignorano gli altri, come se uno scrittore fosse responsabile di tutti i particolari del suo paese, dai mezzi di trasporto fino alla verniciatura delle cassette per le lettere, più di un altro cittadino, questi avversari per malinteso e per caso avviliscono ciò che hanno in comune e ciò che potrebbe costituire la loro misura: la loro lingua e l’uso che ne va fatto.
Le parole sono segni, ci dice Martin Walser, e se tornano alla mente alcune frasi vuoi dire che alludono a qualcosa che non riusciamo a cancellare o a allontanare da noi: “Di chi è la colpa, se già dal mattino presto la lingua mi passa come in un gioco queste quattro parole? La crocifissione di un gatto . E della lingua? Ma “la lingua [...] non esiste’. O meglio, “è quello che sono io stesso”: cresce con me, “indistinguibile da me. Giacché il luogo della lingua è la memoria. Che è fatta della stessa materia della storia”. Se “la crocifissione di un gatto” mi rimbalza nella mente, forse vuoi dire che mi lancia “un segnale, quasi una specie di ordine”. Mi chiede di risalire al passato: “Quello che è accaduto, viene custodito nella lingua, nella memoria, nella storia, in me, in tutti: bisogna aspettarsi che la lingua ce lo ricordi, anche se si preferirebbe dimenticarlo” .
È la lingua che richiama in vita il passato. E la lingua tedesca è doppiamente ferita: sia dal nazismo, sia dal presente. Liberarsi dalla colpa contribuisce “alla nostra salute spirituale”, ha affermato recentemente Kolakowski, tornando sull’idea della responsabilità collettiva: “Noi non siamo personalmente responsabili per i nostri predecessori: ma se crediamo nel fatto che una nazione sia un insieme spirituale e morale che mantiene nel tempo la sua identità malgrado le generazioni che muoiono e le nuove che le sostituiscono, è giusto credere che accanto alla responsabilità singola esista anche quella collettiva, cioè quella della nazione come continuità” .
Si è parlato di un’unità nuova che i francesi pensavano come figura “di un comunismo metafisico”. Un’unità plurale, fondata sulla letteratura, in cui le differenze non solo non vengono soppresse ma costituiscono la condizione della sua possibilità:
Forse uno dei malintesi che ci agitano viene di qui: i nostri testi potrebbero apparire reazionari a coloro che si ostinano a leggerli nella prospettiva pre-unitaria, mentre per noi rappresentano un approccio alla questione fin d’ora aperta, in quanto appartengono alla `fine della filosofia’. Tutto accade come se bisognasse sempre pensare - dire - il mondo due volte, una prima volta nella prospettiva dell’unità e in rapporto all’avvento del tutto, una seconda volta nell’affermazione della differenza e dell’esigenza della discontinuità
Ma è proprio la diversa idea di letteratura ad alimentare malintesi diffidenze sospetti. E sono i francesi che si distinguono dagli altri due gruppi, tanto da far nascere equivoci e da venir continuamente fraintesi. Italiani e tedeschi li accusano di non volersi misurare con le cose , mentre per loro l’unica realtà dello scrittore è la letteratura; l’unica verità da ricercare è la verità della parola; l’unica cosa di cui occuparsi è il linguaggio. Italiani e tedeschi sembrano ancora prigionieri del ricatto del realismo e del rappresentare , mentre i francesi, se si rifiutano al racconto , è perché vogliono uscire dalla scena della rappresentazione; se elaborano la nozione di frammento è perché vi intravedono la sola forma che tangibilmente la nega . La loro scelta è anche una proposta politica: perché il frammento è la voce della differenza e della pluralità e, a un tempo, nega la dialettica e lo storicismo che stabilisce un continuum fra il passato e il futuro. Purtroppo, neppure Vittorini, per quanto si senta alieno dalla dialettica hegeliana, capisce fino in fondo il senso della scrittura per frammenti e nella lettera a des Forèts del 26 gennaio 1963 ne parla come di una forma o di uno stile individuale, caratteristico solo di alcuni scrittori. L’incomprensione fra i gruppi si fa esplicita nel giudizio di Bochlich sul lavoro dei francesi (il loro orientamento è “privo di riferimenti”) e nelle parole accorate di Blanchot, cui sembra di vedere di colpo tornati i vecchi fantasmi: “È arrivato a criticare i nostri testi come un critico della cultura e un ideologo. Un modo che ci sembra pericoloso, perché giudica l’atto letterario sulla base di criteri estetici e ideologici impliciti cui, a nostro avviso, non si possono sottomettere i testi degli scrittori. Per me, l’atto o l’esperienza letteraria è indivisibile: si accetta o si rifiuta per intero” .
Il giudizio di Boehlich, redattore della Suhrkamp, è anche un segno del peso che sempre più le case editrici coinvolte nel progetto assumono nei confronti degli scrittori. Boehlich rimprovera Blanchot d’essere “astratto” e di neutralizzare nel simbolico un evento concreto come il muro di Berlino. Ma quell’evento doloroso non era un problema solo nazionale; era il problema della divisione. Quanto all’astrattezza, il muro “ha inteso astrattamente concretizzare la divisione, renderla visibile e tangibile”, diceva Blanchot. E indicava la sua importanza e il suo scandalo “nel ricordarci ciò che di continuo dimentichiamo: che l’astrazione [...] è il nostro mondo, quello in cui giorno per giorno viviamo e pensiamo” . Il problema di Berlino, pur nella sua specificità, riguardava tutti: era un segno della frattura dell’Europa . E fu anche una delle cause principali del fallimento di «Gulliver», per quanto i francesi continuassero a ripetere che la reciproca diversità culturale e politica era la base su cui costruire una rivista internazionale nuova.