Più passano gli anni, più la figura di Antonio Delfini scrittore e moralista cresce d’importanza agli occhi dei contemporanei. Non è infatti un caso che egli, per una parte consistente dei giovani scrittori e non solo, sia un esempio e forse perfino un modello, e non perché ne manchino; tra i contemporanei ci sono infatti scrittori notevoli, ma Delfini è per molti qualcosa di più di un riferimento. Eppure, se c’è qualcosa d’inimitabile, è proprio la scrittura di Delfini, il suo modo tutto particolare di fare «letteratura», senza farla mai.
Lo scrittore modenese è in apparenza il più antiletterario degli scrittori contemporanei, quello che più sfugge alle classificazioni e alle tassonomie. E ciò che un tempo si sarebbe detto un difetto - non avere il suo bravo centone nelle pagine delle storie letterarie patrie - oggi è solo il segno tangibile di un vantaggio che lo scrittore Delfini ha accumulato su molti. Questo non in virtù di qualche riuscita operazione di marketing culturale, ma per quel naturale e benefico effetto che il tempo ha sull’opera di chi ha scritto, dipinto o scolpito in un dialogo serrato e implacabile con se stesso. Ma Delfini non è importante solo per gli scrittori - in apertura di questo volume ve ne sono alcuni che, in maniera diversa, dialogano con lui - o per i pittori - qui se ne sono raccolti tre, ma il numero di coloro che leggono e rileggono con attenzione Delfini è tra di loro più vasto - bensì per tutti noi.
Ha ragione Cesare Garboli, quando di recente ha ribadito che Delfini riappare al nostro orizzonte in momenti particolari, anche se non sempre felici o fortunati. Forse si potrebbe aggiungere che questo avviene sempre in momenti decisivi della storia morale e civile del nostro Paese. È capitato a metà degli anni Cinquanta, quando venne ristampata la Basca, poi a metà del decennio successivo, subito dopo la sua morte, e così all’inizio degli anni Ottanta, il nostro ancora incombente passato prossimo. La ragione di quella che potrebbe sembrare una semplice casualità è da ricercarsi nelle pagine di quella Introduzione alla Basca, dove un Delfini deluso, addolorato, ma non domo, ha ricostruito in un meraviglioso e lirico racconto sospeso tra sogno e lucida analisi, la storia della sua anima che è anche la storia dell’anima italiana.
La ragione della continua attualità di Delfini, della sua esemplarità, è tutta in questa per lui tragica coincidenza che, in modo più o meno diretto, le pagine qui raccolte raccontano: pochissimi scrittori hanno incarnato in modo così perfetto la storia dell’anima di questo secolo come il «perdente» Delfini. Perciò Delfini è uno scrittore appassionatamente civile, proprio come lo è stato l’amatissimo Leopardi, così impastato con gli umori della sua terra da poter denunciare uno dei difetti dell’anima italiana, il provincialismo: «il complesso d’inferiorità si chiama (e si chiama tutt’ora) provincia. Si badi però a quanto dico. Il loro complesso non stava nell’essere dei provinciali (che non esistono e non sono mai esistiti) ma nel parlare, nel giudicare, di una provincia, di un provincialismo, nel contagiare di un timore della provincia, e nell’isolarsi in una torre, o in una valle segreta, o nel centro di una grande città, o nel salotto di una signora dentro una villa, fuori della provincia».

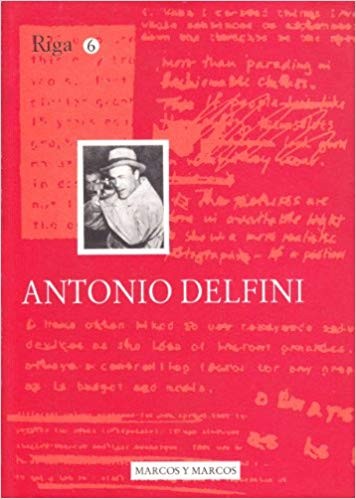


 torna su
torna su scarica tutto l'editoriale
scarica tutto l'editoriale